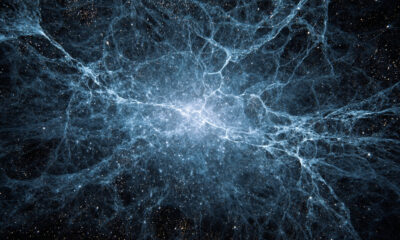Pensiero
Nelson Mandela e il green pass

Crediamo che il green pass – e il passaporto vaccinale, e il 2G, e ogni altro nome con cui i vari Paesi danno un nome al lasciapassare COVID – costituisca un’apartheid vera. Su questo sito la chiamiamo spesso con l’espressione «apartheid biotica». Ci sembra incredibile che ci venga ora venduto un concetto di «libertà» che passa attraverso la segregazione di una parte della popolazione. Ma è così.
Si tratta di una prima assoluta per la triste storia della discriminazione umana: non si è discriminati per colore della pelle, lingua, appartenenza etnica, ideologia – si è discriminati ad un livello biologico, perfino, subcellulare, biomolecolare.
Abbiamo tutti visti i parossismi a cui si è arrivati. Come se niente fosse, Paesi interi hanno diviso supermercati e bar tra un segmento biotico della popolazione e l’altro – i vaccinati hanno i loro tavolini, magari fuori, e in tanti posti non possono entrare. «Come i fumatori una volta», minimizza qualcuno. No, in realtà i fumatori in piscina potevano andare, bastava che non vi fumassero.
Siamo dinanzi ad un progetto di ingegneria sociale sacrificale: la cancellazione delle minoranze
Come se niente fosse, si è stabilito quello che qualcuno potrebbe definire un nuovo razzismo, basato sulla marchiatura mRNA. Il genetista Lee Silver, un entusiasta di quella che battezzò «riprogenetica», cioè la creazione sempre più artificiale di bambini bioingegnerizzati, disse nel suo libro di fine anni Novanta Il paradiso clonato che la società si sarebbe presto divisa in due tronconi: da una parte i GenRich, la popolazione geneticamente arricchita, creature con DNA manipolato per essere più belli, più sani, più funzionali; dall’altro i Natural, coloro che, per fede religiosa, arretratezza, o anche solo per sfortuna sono venuti al mondo attraverso gestazione e concepimento naturali.
Silver sosteneva che queste due classi sociali si sarebbero distinte al punto tale che i Natural sarebbero finiti giocoforza a fare i lavori domestici in casa dei GenRich. Non solo: andando avanti nel tempo, la diversità genetica dei due gruppi sarebbe diventata tale che incroci tra le due «razze» sarebbero diventati biologicamente impossibili.
Ebbene, non siamo ancora passati per l’ingegneria genetica (ma, il lettore di Renovatio 21 lo sa, ci stiamo arrivando), ma siamo pienamente davanti ad una società divisa oramai in due classi biologiche – e, per inciso, a dividerle c’è appunto una tecnica genetica, il mRNA.
L’apartheid dei non vaccinati è una realtà che si farà sentire in modo sempre più osceno. Al momento, in Austria e in Germania abbiamo il lockdown per i soli non vaccinati, quindi i lager, già attivi in Australia e, a quanto consta da una legge appena votata a Vienna, di possibile prossima apertura in un Paese limitrofo.
Tuttavia, è stato notato, se guardiamo all’apartheid esperito dai neri africani, le differenze balzano all’occhio. Ai neri sudafricani non veniva impedito di uscire di casa. Ai neri sudafricani non veniva impedito di lavorare. Ai neri sudafricani non era chiesta un’alterazione genetica. Ai neri sudafricani non era orrendamente concesso di prendere gli autobus dei bianchi, ma gli autobus per i neri c’erano.
In pratica, le condizioni dei neri sotto l’apartheid sudafricano erano migliori di quelle di tanti non vaccinati sotto il regime della tirannide sanitaria.
In pratica, le condizioni dei neri sotto l’apartheid sudafricano erano migliori di quelle di tanti non vaccinati sotto il regime della tirannide sanitaria
A questo punto, è impossibile non tirare fuori la storia dell’icona della lotta all’apartheid, Nelson Mandela.
Non ci è possibile provare simpatia per quello che è stato preconfezionato dal mondo «laico» (cioè massonico e globalista) come un santo «laico» (cioè massonico e globalista) del XX secolo, al pari di Gandhi e Martin Luther King – il fondatore di Renovatio 21 ha scritto a riguardo un ebook, e ne ha parlato anche in un capitolo di un altro libro.
Mandela era un terrorista: così era considerato, e a ragione, dal governo sudafricano dell’apartheid. Venne imprigionato perché il suo partito, l’ANC (che era pesantemente influenzato dall’URSS e dai suoi satelliti) aveva abbandonato i metodi costituzionali e intrapreso la via della lotta armata: sabotaggi, con morti e feriti, e addestramento di un ala militare per futuro uso.
Nelson Mandela, l’idolo celebrato da coloro che oggi impongono la tirannide biotica, avrebbe qualcosa da raccontare. Qualcosa che interroga, nel profondo, il senso stesso della democrazia
Sugli attentati da loro perpetrati, con morti innocenti, si potrebbe scrivere a lungo, così come dell’orrido modo in cui giustiziavano i loro stessi uomini – una copertone in fiamme intorno al collo e via, con tanto di canzoncina che celebrava il necklacing, la cosiddetta «collana»: «With our boxes of matches, and our necklaces, we shall liberate this country», con la nostra scatola di fiammiferi, e le nostre collane, libereremo questo Paese…
Tuttavia, proprio Nelson Mandela, l’idolo celebrato da coloro che oggi impongono la tirannide biotica, avrebbe qualcosa da raccontare. Qualcosa che interroga, nel profondo, il senso stesso della democrazia.
Mandela fu arrestato nel 1962. Seguì il cosiddetto Rivonia Trial, il processo, durato dall’ottobre 1963 al giugno 1964, che terminò con la condanna all’ergastolo comminata a Mandela per cospirazione per rovesciare lo Stato.
«Sono accusato di aver incitato le persone a commettere un reato in segno di protesta contro la legge, una legge nella cui preparazione né io né alcun membro del mio popolo abbiamo avuto voce in capitolo»
Mandela, al termine del processo, tenne un discorso divenuto storico, considerato oggi uno dei momenti fondanti del Sudafrica attuale, sorto dopo 27 anni di prigionia del leader. Era il 20 aprile 1964.
Vengono citate spesso, e a ragione, la bellezza e la poesia del suo idealismo civile:
«Durante la mia vita ho dedicato me stesso a questa lotta del popolo africano. Ho combattuto contro la dominazione bianca e ho combattuto contro la dominazione nera. Ho coltivato l’ideale di una società democratica e libera in cui tutte le persone vivranno insieme in armonia e con pari opportunità. È un ideale per il quale spero di vivere e di vedere realizzato. Ma, mio Signore, se è necessario, è un ideale per il quale sono pronto a morire».
Gli avvocati di Mandela erano contrari all’inserzione di questo riferimento alla morte: temevano che avrebbe potuto portare la sentenza verso la pena capitale. Mandela volle includere lo stesso queste parole.
È possibile per una larga fetta della popolazione, subire una legge sulla quale non ha avuto alcuna voce in capitolo?
Tuttavia, politicamente e filosoficamente più significativo fu la prima dichiarazione in tribunale, nel 1962.
«Sono accusato di aver incitato le persone a commettere un reato in segno di protesta contro la legge, una legge nella cui preparazione né io né alcun membro del mio popolo abbiamo avuto voce in capitolo».
«Nel soppesare la decisione sulla pena da infliggere per un simile reato, il giudice deve tener conto della questione della responsabilità, se sono io responsabile o se, di fatto, gran parte della responsabilità non ricade sulle spalle del governo che ha promulgato quella legge, sapendo che il mio popolo, che costituisce la maggioranza della popolazione di questo Paese, si è opposto a quella legge, e sapendo inoltre che ogni mezzo legale per dimostrare tale opposizione è stato ad esso precluso dalla legislazione precedente e dall’azione amministrativa del governo».
Mandela parla dell’impasse definitivo della democrazia: una parte della popolazione non ha più alcun canale per esprimersi.
Ma più ancora, il leader sudafricano nelle righe dà respiro ad uno dei più grandi temi della democrazia, quello che il politologo di Yale Ian Shapiro chiama «principle of affected interest», il «principio dell’interesse colpito».
È possibile per una larga fetta della popolazione, subire una legge sulla quale non ha avuto alcuna voce in capitolo?
Oggigiorno, ci troviamo esattamente nella posizione di Mandela. Leggi terrificanti – leggi di apartheid peggiore di quello sudafricano – vengono implementate senza che né nel governo né in Parlamento vi sia la benché minima rappresentazione di una una percentuale di popolazione a doppia cifra che rifiuta completamente le politiche in atto
«La posizione di Mandela era che il principio dell’interesse colpito era stato violato» sostiene Shapiro. «Questa nozione è molto vicina alla più fondamentale idea procedurale della teoria democratica, cioè che le persone i cui interessi sono colpiti da una decisione, presumibilmente dovrebbero avere qualche voce in capitolo nel prendere quella decisione».
Ciò è particolarmente vero nei casi in cui la popolazione non abbia un’espressione di rappresentanza democratica – la scintilla che fece scoccare l’ora della Rivoluzione Americana, quel «No taxation without representation» inovato dal Tea Party. Se ci vuoi tassare, vogliamo avere una rappresentazione all’interno del processo decisionale sulle tasse.
Siamo praticamente nel cuore della giustizia democratica. Senza rappresentazione di vaste porzioni della popolazione — specialmente quelle in dissenso con il potere! – non vi è giustizia e non vi è, come da etimo, potere del popolo. La forma di governo risultante è sola una forma di tirannide che si fa chiamare cosmeticamente «democrazia».
A questi milioni di dissidenti senza alcuna rappresentazione, senza alcuna voce del processo decisionale, è chiesto il sacrificio del proprio corpo biologico e della propria morale
Oggigiorno, ci troviamo esattamente nella posizione di Mandela. Leggi terrificanti – leggi di apartheid peggiore di quello sudafricano – vengono implementate senza che né nel governo né in Parlamento vi sia la benché minima rappresentazione di una una percentuale di popolazione a doppia cifra che rifiuta completamente le politiche in atto.
Di più: a questi milioni di dissidenti senza alcuna rappresentazione, senza alcuna voce del processo decisionale, è chiesto il sacrificio del proprio corpo biologico e della propria morale. Leggi, ripetiamo con Mandela, «di cui né io né alcun membro del mio popolo abbiamo avuto voce in capitolo nella preparazione».
Cosa diviene quindi la democrazia?
I governi di tutto il mondo, oggi, perseguono l’esatto contrario: la disintegrazione degli individui dotati di ragione, e la preservazione di masse di persone irrazionali e manipolabili a piacimento, sia che li si chiuda in casa per mesi che gli si innesti una sostanza di alterazione genica
«La democrazia può essere il peggiore dei mali, la peggiore delle tirannie. Perché non c’è una tirannia peggiore della massa irrazionale, della folla dei linciatori». Lo abbiamo sentito in un articolo pubblicato ieri, il grande discorso di Lyndon Larouche sulla Legge Naturale come unica vera patria dell’essere umano.
«La democrazia come alcuni la definiscono è la democrazia della folla linciatrice, nei confronti della quale è importante non avere il colore della pelle sbagliato, o non avere il colore d’opinione sbagliato, entro la quale l’individuo non ha altro diritto all’infuori del diritto di essere d’accordo con ciò che sembra essere l’opinione dominante».
È esattamente così, come con Mandela: l’unico diritto che abbiamo è quello di essere d’accordo con l’opinione dominante, che oggi chiamano, sempre più sfacciatamente, «narrazione». Devi credere a tutto quello che ti dicono, anche quanto ciò che ti viene inculcato è spudoratamente privo di logica, e quello che ti viene iniettato è privo di garanzie di sicurezza (non per nulla, te lo portano i militari…). Altrimenti: scherno, emarginazione, magari pure l’espulsione dal discorso pubblico, la damnatio memoriae odierna che passa per i social media. Magari, poi, anche qualche manganellata, o un cane che vi sbrana davanti a tutti, o finanche un paio di pallottole.
Siamo dinanzi ad un progetto di ingegneria sociale sacrificale: la cancellazione delle minoranze.
Ci troviamo quindi ad un impasse storico – o forse, ad una mutazione politica epocale. La democrazia non rappresenta più i cittadini – solo, programmaticamente, alcuni di essi. Gli altri sono ignorati, o combattuti fino ad avvenuta sottomissione
Lo Stato democratico dovrebbe, in teoria, includere il dissenso, quando esso è basato non sulla barbarie irrazionale, ma sulla ragione. Lo Stato dovrebbe fornire la possibilità di parola, di ragione – di Logos – a tutti gli uomini che del Logos sono figli.
«La difesa dell’individuo che desideri ragionare, che intenda essere governato dalla Legge Naturale e dalla ragione, è il compito più sacro della società» diceva Larouche. «La difesa e lo sviluppo di tali individui è il compito della società».
I governi di tutto il mondo, oggi, perseguono l’esatto contrario: la disintegrazione degli individui dotati di ragione, e la preservazione di masse di persone irrazionali e manipolabili a piacimento, sia che li si chiuda in casa per mesi che gli si innesti una sostanza di alterazione genica.
Ci troviamo quindi ad un impasse storico – o forse, ad una mutazione politica epocale. La democrazia non rappresenta più i cittadini – solo, programmaticamente, alcuni di essi. Gli altri sono ignorati, o combattuti fino ad avvenuta sottomissione.
La democrazia, nata con l’intento di lasciare libera l’espressione dell’individuo, ora è divenuta censura e violenza. La democrazia è divenuta tirannide e schiavitù. La libertà è divenuta apartheid. Apartheid biotica.
La democrazia, pensata per includere le minoranze, ora progetta la loro eliminazione, politica e forse non solo politica.
La democrazia, nata con l’intento di lasciare libera l’espressione dell’individuo, ora è divenuta censura e violenza.
La democrazia è divenuta tirannide e schiavitù.
La libertà è divenuta apartheid. Apartheid biotica.
Roberto Dal Bosco
Immagine Laurel di via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), immagine modificata.
Pensiero
Tucker Carlson: questa è la guerra di Israele

Renovatio 21 pubblica la trascrizione del monologo di Tucker Carlson.
Ogni volta che accade qualcosa di grande, in particolare qualcosa di veramente grande, come una guerra che cambierà la storia del mondo, le prime quattro domande che bisogna porsi sono queste. Primo, perché è successo? Secondo, qual era lo scopo? Terzo, come andrà a finire? E quarto, come rispondiamo? Valutiamo la guerra in Iran, ora in corso al suo secondo giorno, e cerchiamo di rispondere a queste quattro domande. Primo, perché è successo? Ora, in questo caso, la risposta è molto semplice. È successo perché Israele lo voleva. Questa è la guerra di Israele. Non è la guerra degli Stati Uniti.
Questa guerra non viene condotta per gli obiettivi di sicurezza nazionale americani, per rendere gli Stati Uniti più sicuri o più ricchi. Questa guerra non riguarda nemmeno armi, distruzione di massa, armi nucleari, kembio. No, questa guerra viene condotta semplicemente perché Israele la voleva. Per essere condotta. Ora, perché dirlo ad alta voce in questo momento del conflitto? Non è forse motivante per, diciamo, le truppe americane che combattono questa guerra? Sì, lo è. Abbiamo riflettuto a lungo se fosse saggio o decente dire una cosa del genere ad alta voce e abbiamo deciso che lo è per il seguente motivo.
Innanzitutto, perché la verità è sempre l’unica base per un processo decisionale saggio. Quando menti a te stesso o alla tua gente, non solo commetti, beh, un crimine morale mentendo, ma tendi anche a farti del male. L’arroganza è il prodotto delle bugie, per esempio. Ti fai prendere dall’orgoglio se non sei onesto con te stesso e con le persone intorno a te su ciò che sta accadendo e sul perché sta accadendo. Ma a lungo termine, anche questo è vero. In altre parole, è importante spiegare perché questa guerra sta accadendo, perché tra 50 anni la gente potrebbe non saperlo. I tuoi nipoti potrebbero scoprire che questa guerra è iniziata perché l’Ayatola è apparso a Miami e ha iniziato a mitragliare la gente in un centro commerciale. E così abbiamo risposto, c’è stata una Pearl Harbor iraniana.
Non sai cosa crederà il futuro del presente. Non sai come verrà scritta la storia. E se sei scettico al riguardo, se ti chiedi: «Beh, come hanno potuto gli storici, gli storici popolari, come hanno potuto la cultura futura fraintendere qualcosa di così grande?» Come si può mentire su qualcosa di così ovvio, di così gigantesco? Beh, la storia è la vostra guida. Molti dei grandi eventi che crediamo di comprendere, comprese le guerre del passato e di un passato non così lontano, sono completamente distorti nei nostri ricordi.
In altre parole, non è affatto quello che è successo. La verità è che, se un numero sufficiente di persone mente su qualcosa a un volume sufficientemente alto, e lo fa abbastanza a lungo, abbastanza forte, minacciando chiunque si rifiuti di mentire, col tempo le sue bugie diventano saggezza convenzionale. Tutti ci credono. C’è qualcosa nel ripetere una bugia più e più volte che è quasi come un incantesimo o una formula magica. È quasi una forma di stregoneria. Presuppone la realtà o una versione della realtà, una realtà surrogata, una realtà falsa. Ma la realtà è pur sempre realtà, e se siete interessati alla storia, tornando indietro di migliaia di anni o anche più recentemente, sapete che la comprensione di certi eventi di cui siete cresciuti sentendo parlare, probabilmente si è completamente capovolta.
È vero il contrario, ma non lo sapevate finché non avete scavato un po’ più a fondo, in alcuni casi molto più a fondo, per scoprirlo, perché sono stati distorti nella narrazione. E poiché lo sono state, poiché molti dei nostri presupposti più basilari si basano su falsità, finiamo per ritrovarci sempre negli stessi guai. Quindi è importante dire la verità fin da subito.
Questo, tra l’altro, è ampiamente noto. Non è una teoria del complotto. Tutti lo dicono ad alta voce ora perché è vero. Gli Stati Uniti hanno impegnato truppe in questo conflitto perché il Primo Ministro di Israele, non Israele come nazione, ma colui che lo gestisce, Benjamin Netanyahu, Bibi, lo ha richiesto. Sette viaggi alla Casa Bianca nell’ultimo anno. Lo scopo di quei viaggi non è mai cambiato. Gli Stati Uniti devono impegnarsi per un cambio di regime in Iran. Abbiamo bisogno che l’esercito americano rovesci il governo dell’Iran. E lo stesso Bibi ha sostanzialmente detto questo, che non pensavamo che l’Iran avrebbe ottenuto l’arma nucleare questa settimana, ed è per questo che l’abbiamo fatto. Nessuno lo dice nemmeno ora. Lo faranno in futuro, quando i nostri ricordi si saranno un po’ offuscati e potranno manipolarci di più. Ma in questo momento stanno ammettendo: «no, in realtà, non erano sul punto di ottenere l’arma nucleare». Lo stesso Bibi ha detto: «Puoi guardare il video. Lo sogno da 40 anni». Finalmente ce l’abbiamo fatta.
Quindi questo è il culmine di un piano strategico a lungo termine. In realtà, se si guarda indietro e si cerca di valutare gli eventi recenti, anche in questo Paese, nella vita politica americana degli ultimi anni, certamente degli ultimi sei o otto mesi, si può vedere che molto di ciò che stava accadendo qui era in preparazione per la situazione attuale.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
In altre parole, chi voleva la guerra in Iran stava ammorbidendo l’opinione pubblica, manipolando il governo degli Stati Uniti per influenzarlo e facendo del loro meglio per mettere a tacere chiunque ne dubitasse. Molte delle cose a cui abbiamo assistito nel recente passato sono, e ora è ovvio, tutte progettate per portarci dove siamo ora: una guerra con l’Iran per conto di Israele. Ora, solo una precisazione iniziale: solo perché il Primo Ministro israeliano voleva una guerra con l’Iran per un cambio di regime non significa in alcun modo che fosse un’idea saggia per Israele.
Di certo non è stata una buona idea per gli Stati Uniti. Nessuno lo contesta. Ma è stata una buona idea per il Paese o per il Primo Ministro che l’ha sostenuta? No, probabilmente no, in realtà. Solo perché vogliamo qualcosa non significa che sia un bene per noi. A volte, quando otteniamo ciò che desideriamo di più, ne veniamo distrutti. Spero che questo non accada a Israele, ovviamente, o a chiunque altro, ma potrebbe. Quando si arriva alla verità delle cose e si vede chi le sta sostenendo, ciò non significa che quella persona capisca i propri interessi o quelli del suo Paese: spesso non lo fanno, spesso non lo facciamo noi.
Ma questo non cambia il fatto che siamo arrivati a questo punto perché Israele ha fatto pressioni. E praticamente tutti nel governo degli Stati Uniti, certamente al Pentagono, ne hanno compreso i rischi. I rischi erano evidenti fin dal primo giorno. Innanzitutto, se si elimina un governo, abbiamo una lunga storia in questo campo, non è poi così difficile. Il coraggio individuale del personale militare statunitense, dei soldati che lo fanno, è lodevole, impressionante, a volte sorprendente. Ma questa è, come abbiamo imparato, la parte facile. Uccidere Saddam? Ok, sorprendente. Cosa viene dopo? Eccetera, eccetera.
Tutto questo è molto, molto noto. Era risaputo, 48 ore fa, che non c’era un vero piano per sostituire il governo che speravamo di rovesciare, e a quel punto, cosa? Beh, ora abbiamo un Paese, l’Iran, grande quanto l’Europa occidentale, con 92 milioni di persone, un Paese che è solo poco più della metà persiano, che ha le sue divisioni interne, dinamiche e rivalità. Quel Paese è potenzialmente in disgregazione. E cosa significa? Beh, voglio dire, è difficile vedere questo come una cosa positiva per il resto del mondo a così tanti livelli, che preghiamo non diventino più evidenti, ma che stanno diventando evidenti anche adesso.
Potrebbe essere un vero, vero disastro. Quindi perché dovremmo volerlo? Beh, certo, non lo vorremmo. L’unico Paese che sembra volerlo è l’unico leader. Per essere onesti, ancora una volta, non parlo a nome di ogni israeliano più di quanto Joe Biden o Donald Trump o chiunque altro governi questo Paese parli a nome di ogni americano, ovviamente. Ma Benjamin Netanyahu lo voleva. Pensava che fosse la sua missione, ma più che la sua missione, forse il suo destino. Lo ha suggerito nel suo discorso di oggi. Ed ecco perché. Ma nessuno nel governo degli Stati Uniti con cui abbia mai parlato, sentito, citato in TV, sembrava credere che questo fosse principalmente nell’interesse dell’America.
Potrebbero esserci benefici collaterali. Voglio dire, si sentono queste analisi su come il mondo sta cambiando e su come è passato dall’essere unipolare a multipolare. Tutto vero. Gli Stati Uniti hanno governato il mondo incontrastati dall’estate del 1991 fino a, non so, scegli una data, abbastanza recente, l’ascesa della Cina. E all’improvviso, ci sono i multipolari. Ci sono più di una grande potenza che si contendono il controllo del mondo, delle sue rotte commerciali, delle sue risorse, eccetera, eccetera.
E che in qualche modo eliminare il governo iraniano sarebbe un vantaggio per noi in quella complessa partita a scacchi. E questo è un argomento valido, immagino. Queste cose sono difficili da capire. E qualsiasi persona saggia guarda il mondo e dice: «ok, non c’è modo di fermare l’ascesa della Cina». La loro capacità produttiva, il loro potere economico, che è davvero la più grande economia reale del mondo, non finirà domani. Quindi deve esserci un modo per raggiungere un accordo di condivisione del potere con la Cina, con l’Oriente.
Gli Stati Uniti non governano il mondo incontrastati, e nel prossimo futuro probabilmente non lo faranno. Quindi, come possiamo vivere in una parvenza di pace e preservare i nostri interessi? E ancora una volta, si stipula un accordo informale di condivisione del potere con l’altra grande potenza, o con le altre grandi potenze, che probabilmente non possono fermare questo processo. Probabilmente è troppo tardi per impedire alla Cina di controllare l’Oriente a questo punto. Uccidere l’atollo probabilmente non basterà, quindi probabilmente c’è un modo migliore per farlo. Ma in ogni caso, ci sono persone che non sono d’accordo, e se lo facessimo, sarebbe meglio per noi a lungo termine, e almeno bisogna riconoscere loro il merito di aver cercato di pensare a un modo in cui questo potrebbe avvantaggiare gli Stati Uniti.
Ma la maggior parte di coloro che hanno valutato la situazione lo sapeva, non c’entrava assolutamente nulla con noi. Questa è la guerra di Israele. Ecco cos’è. Non è un attacco. Non è un attacco a Israele, tra l’altro. Non si tratta certo di antisemitismo o di odio verso gli ebrei, è un dato di fatto. Un capo di Stato è venuto nel nostro Paese, un capo di Stato di 9 milioni di persone, è venuto in un Paese di 350 milioni di persone e ci ha chiesto di aiutarlo, o di farlo noi stessi, rovesciare il regime di Teheran. Ora, come ottengono la leva per farlo? È una domanda complicata, e vale davvero la pena rifletterci.
Ma come ha fatto questo piccolo Paese senza risorse e con 9 milioni di abitanti a convincere la grande superpotenza mondiale, con il più grande esercito della storia, a fare i suoi voleri in un modo che lo avrebbe danneggiato? Beh, di nuovo, la domanda ha molti risvolti. Ma la risposta più ovvia e immediata è perché Bibi ha detto al Presidente degli Stati Uniti: «puoi unirti a me o no, ma io ci vado». Il Segretario di Stato, Marco Rubio, lo ha detto ieri in una telefonata ai leader del Congresso. Ha affermato che Israele ha detto che se ne sarebbe andato. A quel punto, ci sarebbero solo due possibilità.
Puoi salire a bordo e cercare di aiutare o contenere la guerra di Israele. Questo fa parte del calcolo. Israele ci sta andando. Cerchiamo di mantenere la situazione entro i limiti. Cerchiamo di essere una forza moderatrice in questa avventura, qualunque essa sia, oppure puoi dire di no a Israele, e loro lo faranno e basta. Se lo facessero, non ci proteggerebbero perché ci sono centinaia di migliaia di americani in Medio Oriente, sia in uniforme che senza, civili e militari.
Ci sono anche i progetti petroliferi, le infrastrutture energetiche, il petrolio e il gas più importanti del mondo. Che hanno più di qualsiasi altro fattore che determina l’effetto sull’economia globale. Tutti hanno bisogno del loro petrolio e del loro gas, punto. Non puoi cambiarlo. Mi dispiace. Se quell’infrastruttura viene danneggiata o distrutta, colpisce tutti noi. Non tutti noi, tutti, ma noi. Non puoi semplicemente lasciare che Israele faccia questo. Ora, naturalmente, c’è una terza potenziale opzione teorica, che dici a Israele, che è uno stato cliente, per il quale paghiamo, la cui creazione abbiamo reso possibile. Tu dici: «no, non lo faremo». Capisco. Non ti piace l’Ayatollah, non ti piace l’Iran, ma questo è un male per noi e non ti permetteremo di farlo.
Se lo fate, noi taglieremo gli aiuti, non so cosa. Possiamo esercitare la pressione che è intrinsecamente nostra, visto che stiamo pagando per tutto questo. Ma non era nemmeno sul tavolo. Non è mai stato sul tavolo. Nessuno negli ultimi 63 anni ha mai preso in considerazione l’idea di farlo. In realtà, l’ultimo presidente a farlo è stato John F. Kennedy nel 1962, e si è trovato in una disputa, non famosa come dovrebbe essere, con il Primo Ministro fondatore di Israele, l’allora Primo Ministro di Israele, David Ben Gurion, sul programma nucleare israeliano a Dimona.
Poi il Presidente Kennedy disse: «o, non credo nella proliferazione nucleare. Questo è uno dei pilastri della mia amministrazione, e non si possono continuare a fare test, e io pretendo ispezioni». Naturalmente, non fu in grado di mantenere quelle promesse perché fu ucciso nel novembre del 1963. E la persona che prese il suo posto, il suo vicepresidente, Lyndon Johnson, diede il via libera al programma nucleare israeliano. Quindi quella fu l’ultima volta che un presidente americano disse di no, un no netto a Israele, cercò di frenare le sue ambizioni fondamentali, non del tipo, siate gentili con i palestinesi, la Cisgiordania, ma no, non potete avere armi nucleari o no, non potete, non so, bombardare il Libano o altro.
Sostieni Renovatio 21
Quella è stata l’ultima volta. Per qualche ragione, non è nemmeno sul tavolo. La scelta era: accettare ciò che Israele sta facendo, cercare di limitarlo, o limitarsi a restare a guardare e poi inevitabilmente farsi coinvolgere? La verità è, ed è difficile da dire da orgoglioso americano e da qualcuno che vuole che gli Stati Uniti rimangano potenti nel mondo, una forza per la decenza e l’ordine nel mondo, ma soprattutto, che vuole che l’America rimanga prospera, prospera e pacifica in patria, nel Paese in cui viviamo. È difficile dirlo, ma non sono stati gli Stati Uniti a prendere la decisione.
L’ha fatto Benjamin Netanyahu. E ancora una volta, è importante dirlo, non per scoraggiare nessuno o far sentire nessuno scoraggiato o senza speranza. Non c’è motivo di essere senza speranza a questo punto, ma affinché non accada di nuovo. Dite la verità affinché le persone possano imparare, si spera migliorare e crescere. Ma dite la verità, qualunque cosa accada. Allora la domanda diventa: sappiamo perché è iniziato tutto. Tutto è iniziato perché Israele lo voleva e ha preteso l’intervento dell’esercito americano per farlo. Perché Israele avrebbe dovuto volerlo? Abbiamo già stabilito che questa potrebbe essere una buona idea o meno per Israele, ma perché avrebbero dovuto volerla?
Qual era il loro pensiero? Se si trattava davvero della minaccia che l’Iran costruisse e dispiegasse un’arma nucleare o un missile balistico intercontinentale con testata nucleare puntato su Miami e New York, come ha detto Marc Levin ai suoi poveri ascoltatori l’altro giorno, niente di tutto ciò è vero. Ma se si trattava davvero di questo, come è possibile che questa minaccia sia durata 40 anni? Come è possibile, come ha detto ieri Benjamin Netanyahu, come è possibile che il programma nucleare iraniano sia stato sul punto di costruire e dispiegare un’arma nucleare per 40 anni? Beh, ovviamente non lo è stato. Quello che possiamo discutere sugli obiettivi dell’Iran con le armi nucleari è che probabilmente ne volevano una.
Chi non la vorrebbe? Guardate cosa succede nei paesi che non ne hanno una. Tutti vogliono un’arma nucleare. Ma stavano davvero per ottenerla? No. Quindi qual era il punto? Qual è il punto di tutto questo dal punto di vista di Israele? Beh, il punto è l’egemonia regionale. Semplicissimo. Israele esiste da quasi 80 anni. Israele ha armi nucleari. Israele ha un’economia tecnologica statunitense piuttosto solida, ma soprattutto ha grandi ambizioni. E, a proposito, non è un attacco a Israele. Quale Paese in crescita non ha ambizioni più grandi?
E quale leader megalomane di quel Paese, e ce ne sono molti in tutto il mondo, tra l’altro, non vorrebbe l’egemonia regionale? Egemonia regionale significa avere il controllo della propria regione. Una dottrina mediorientale alla Monroe. Israele vuole essere in grado di determinare, grosso modo, cosa succede nella sua regione, e non vuole vincoli al proprio comportamento. Allo stesso modo, ancora una volta, cercando di essere il più generosi e universalisti possibile in questa analisi, perché è vero, chi non lo vorrebbe? Lo vogliamo?
Certo che sì. Sopportiamo molto per Messico e Canada, ma se all’improvviso iniziassero a limitare le nostre reali ambizioni, faremmo qualcosa al riguardo, credo, o lo farebbe la vecchia America, un Paese normale. E Israele vuole controllare il Medio Oriente, e… Sono l’unica potenza nucleare dichiarata in Medio Oriente? Sono l’unica vera potenza nucleare in Medio Oriente? Si potrebbe discutere. La gente può fare supposizioni, ma sono l’unico Paese di cui sappiamo con certezza che ha un grande arsenale nucleare. Vogliono avere un potere senza pari nella loro regione. Ripeto, non si tratta di una teoria del complotto o di qualcosa di strano da desiderare.
È ciò che ogni Paese vuole, e lo vogliono, e Bibi lo vuole. Si vede come una figura storica, non semplicemente come un primo ministro che lotta per mantenere il suo posto, cosa che è, ma come un grande uomo, come un moderno Mosè o qualcosa del genere, come una figura. E uomini così, uomini con un destino, cambiano per sempre i calcoli della loro nazione. Non fanno piccoli passi, fanno grandi passi. Pensano in grande. Lui pensa in grande a suo merito o a suo discapito, ma è un dato di fatto. E quindi questa guerra è uno sforzo, non semplicemente in aggiunta a tutto il resto.
No, no. È esclusivamente uno sforzo da parte di Israele per raggiungere l’egemonia regionale, il controllo totale. Quindi cosa significa esattamente? Beh, significa che devi spazzare via i tuoi nemici. Nel caso dell’Iran, l’Iran era un nemico di Israele, tra l’altro. L’Iran stava anche finanziando insurrezioni e gruppi militanti nella regione per picchettare e infastidire Israele, uccidere gli israeliani. Questo è tutto Hamas, finanziato dall’Iran, assolutamente. Gli Houthi, finanziati dall’Iran, assolutamente. L’Iran lo stava facendo. È vero. E a Israele non piaceva. Perché avrebbe dovuto? Ma è anche vero che, e non voglio giustificare nessuno, queste sono tutte dinamiche.
Un Paese fa una cosa, un altro ne fa un’altra. Voglio dire, come un matrimonio. Nessuna delle due parti è interamente responsabile di ciò che è andato storto o di ciò che è andato bene. Questa è una relazione. Le persone agiscono l’una contro l’altra, l’una con l’altra, ma sempre l’una contro l’altra. Ogni azione provoca una reazione. E quindi questa storia risale a molto tempo fa, e gli storici onesti rimasti possono districarla. Ma se vuoi controllare il Medio Oriente e il tuo Israele, devi decapitare l’Iran. Non devi ricostruirlo. Probabilmente non lo vuoi nemmeno.
È troppo grande. Ha troppe ricchezze minerarie, troppa energia. Quell’enorme giacimento di gas che condividono con il Qatar, eccetera, eccetera. Probabilmente vuoi solo decapitarlo e renderlo indifeso. Vuoi trasformarlo in un inferno perché è meglio per te perché puoi dominare un inferno. Ora, questo potrebbe causare enormi problemi a valle per tutti gli altri. Potresti avere una crisi dei rifugiati in Europa. Beh, è già successo quando Israele ha destabilizzato la Siria. Potresti avere questa ferita aperta e sanguinante. Oh, è già successo quando Israele ha destabilizzato il Libano, quando Israele ha spinto gli Stati Uniti a uccidere Gheddafi in Libia.
Questa è una cosa in corso. È solo la più grande e la definitiva. Sbarazzarsi del governo iraniano aveva un unico scopo: dare a Israele la possibilità di fare esattamente ciò che vuole in Medio Oriente senza problemi. Ciò che vuole, tra le altre cose, è l’espansione territoriale. Un piccolo Paese, vogliono parti della Libia, anzi, scusate, vogliono parti della Siria, parti del Libano. Sono una potenza espansionista, come la maggior parte delle potenze, in realtà. Sfatiamo il mito. Non si tratta degli ebrei. Si tratta di uno stato nazionale che sta crescendo e cerca di esercitare il suo potere.
È così semplice. Si possono togliere tutti gli aspetti inquietanti e vederla semplicemente in termini di geopolitica convenzionale, e ha perfettamente senso. E parte del motivo per cui non riusciamo a vederlo chiaramente è perché negli Stati Uniti siamo stati così indotti a considerare ogni conflitto tra nazioni come un conflitto morale in cui in qualche modo dobbiamo scegliere tra Churchill, Neville Champerlin e Hitler. Si tratta di uno schema assurdo che restringe la nostra visione e ci impedisce di vedere che è esattamente ciò che è sempre accaduto, ovvero una lotta tra potenze per il primato. Ma ci sono altre componenti, in realtà due, altri due ostacoli sulla strada verso il predominio regionale di Israele.
Il primo è quello che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Il GCC è un’alleanza informale, forse un po’ più formale oggi, ma comprende le sei monarchie del Golfo. Sono gli Stati del Golfo produttori di energia. Questi sarebbero Bahrein, Oman, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita. Questi sono alcuni dei maggiori e più importanti produttori di energia al mondo. Sono tutti stati sunniti, arabi. Sono tutti ricchi e, all’improvviso, ora sono tutti a livello internazionale, o alcuni di loro sono influenti a livello internazionale perché sono la sede della diplomazia globale. Stanno colmando il vuoto lasciato dalla Svizzera, che, per non essere troppo noiosi, ha sostanzialmente preso posizione nel conflitto tra Russia e Ucraina e quindi non è un luogo in cui si possa negoziare in buona fede.
Sono di fatto controllati dall’UE e dalla NATO. Non lo ammetterebbero mai, gli svizzeri, ma lo sono. Rinunciano al segreto bancario. Fondamentalmente non sono più allineati. Ma alcuni di questi Stati del Golfo sono quanto di più vicino si possa immaginare a un non allineato. Certamente, il Qatar lo è. E all’improvviso, ogni conflitto nel mondo viene negoziato in Qatar o, più recentemente, in Oman. E quindi hanno un’autorità morale sulla scena globale.
Hanno una diplomazia molto efficace. La gente li apprezza. La gente ci va anche in vacanza. Hanno le migliori compagnie aeree del mondo. Sono l’ovvio snodo turistico regionale per il globo. Sono letteralmente il punto di incontro tra Oriente e Occidente. Se voli da New York a Delhi, farai scalo a Dubai. Hanno compagnie aeree sovvenzionate dal governo che sono assolutamente fantastiche. La gente ha una certa familiarità, una conoscenza diretta di questi Paesi, che 25 anni fa erano un mistero per la maggior parte degli occidentali. Quando è successo l’11 settembre, è stata la prima volta che sono andato nel Golfo, la maggior parte degli americani non ci è mai stata. A meno che non lavorassi nel settore petrolifero o qualcosa del genere, non ci sei mai stato.
Potresti immaginare che fosse tutto danzatrici del ventre, cammelli e schiavitù o qualsiasi altra cosa pensassi. Ma all’improvviso, ogni altra persona ricca in America è stata a Dubai perché sono tutti in viaggio da qualche parte. Stanno facendo un safari in Africa. È stato demistificato all’Occidente, e alla gente piace. Sono società con problemi, certo, ma sono anche ordinate, pulite, elaborate, cortesi, accoglienti con gli stranieri, ricche e un po’ meno appariscenti di quanto ci si aspetterebbe. Sono in realtà alcune delle società più funzionali al mondo, e la gente le apprezza nonostante la propaganda.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
E a proposito, nonostante alcune complicazioni. Ci sono molte cose degli Stati del Golfo che non piaceranno agli occidentali, o comunque alcune cose, e certamente parti della loro politica estera che lasciano perplessi. Ma questa non è la Corea del Nord. È l’opposto. Sono in realtà paesi molto civili. E non sono tutti d’accordo con i programmi di Israele perché hanno popolazioni che non sono d’accordo con il modo in cui Israele ha trattato i palestinesi. Nel caso dell’Arabia Saudita, hanno la Mecca e Medina, i due luoghi più sacri dell’Islam. Ogni musulmano che può è tenuto ad andare in Arabia Saudita durante l’hajj, a visitare la Mecca. Quindi questi sono paesi con un potere intrinseco nel mondo islamico, un potere e risorse in crescita a livello globale.
E quindi non possono essere ignorati. Se mai dovessero unirsi, se questi sei paesi dovessero mai formare, diciamo, una vera alleanza militare, rappresenterebbero una minaccia enorme per Israele. Israele ha trascorso decenni a fomentare il dissenso tra loro, ovviamente. Questo non è necessariamente solo un attacco a Israele. Voglio dire, come chiunque può dirti, passiamo del tempo in Medio Oriente, gli arabi hanno molte grandi qualità, ma amiamo combattere gli uni contro gli altri.
È come il loro hobby preferito, più delle corse di cammelli. È molto facile far litigare e combattere le nazioni arabe, e la sfiducia risale a molto tempo fa, ed è impenetrabile per chi è esterno. Ma se si cercasse di dividere sei paesi l’uno dall’altro, non sarebbe così difficile. Gli israeliani hanno lavorato duramente per riuscirci. Ma la verità è che, se si vuole davvero il controllo del Medio Oriente, bisogna degradare, se non distruggere, gli Stati del Golfo. Gli israeliani lo sapevano, e anche gli americani lo sapevano, forse non era una valutazione così realistica, ma avevano un po’ di buon senso.
Gli israeliani sapevano sicuramente che se si inizia a fare pressioni per lanciare missili contro l’Iran, e se si inizia a uccidere la leadership iraniana, e se, per esempio, si uccide il capo di stato/leader religioso di una branca dell’Islam, l’ayatollah, se si fa ciò, si provoca una risposta militare che danneggia gravemente il Golfo, e che in alcuni paesi, come il Bahrein, sede della Quinta Flotta, si potrebbe potenzialmente alimentare una vera e propria rivoluzione perché quel Paese è quasi, credo, per metà sciita. Quindi, se si fa questo, si potrebbe causare un caos enorme nel Golfo.
Ora, quello non era un rischio dal punto di vista israeliano. Era questo il punto. Era questo il punto. Volevano sminuire il Golfo, e in due giorni ci sono riusciti. Credo che chiunque ami la decenza, l’ordine e la pulizia speri che il Golfo si riprenda. Il Golfo non è una minaccia per noi. Abbiamo basi militari in questi Paesi. Questi sono alcuni dei nostri alleati più stretti. Sono tutti alleati di gran lunga più stretti di Israele. Sono nostri amici, ma sono stati davvero danneggiati. In un posto come Dubai, che è fondamentalmente parte di un Paese, è un Emirato all’interno degli Emirati Arabi Uniti, ma è anche un marchio di lusso, in pratica.
La gente va a Dubai perché è bella, ricca e pulita, e soprattutto perché è sicura e ordinata. Ha l’aeroporto più trafficato del mondo. Inizi a vedere video su Instagram del fumo nell’aeroporto di Dubai e pensi: «Penso che quest’anno andrò a Kabul». Oh, scusa. Cartelli della droga. Va bene. Magari vai a Sedona quest’anno. Fa davvero, davvero male a questi paesi. E Israele voleva far male a questi paesi. Questo è il punto. Voleva far male a questi paesi. Voleva seminare caos e disordine perché sono rivali di Israele.
Quindi probabilmente no, non è stato riportato, ma è un fatto che ieri sera in Qatar e Arabia Saudita le autorità hanno arrestato agenti del Mossad che progettavano di commettere attentati in quei paesi. Ora, questo è strano. Non ha alcun senso. Perché gli israeliani dovrebbero commettere attentati in due paesi del Golfo che sono anche sotto attacco da parte dell’Iran? Non sono dalla stessa parte? No. No. Israele vuole danneggiare l’Iran, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, il Bahrein, l’Oman e il Kuwait. E ci sono riusciti. La terza cosa che si dovrebbe fare se si volesse un vero controllo sulla regione, cosa che, come abbiamo stabilito, Israele vuole e non dovrebbe essere attaccato per questo.
È una cosa naturale volerlo. Ma l’ultima cosa che si dovrebbe fare è far uscire gli Stati Uniti dal Medio Oriente. Dal 1948, gli Stati Uniti, da Harry Truman ad oggi, i presidenti degli Stati Uniti, e come notato con sempre minore successo, hanno cercato di limitare o plasmare le politiche di Israele, la sua politica estera. Abbiamo il diritto di farlo perché siamo il Paese più potente del mondo, lo siamo dal 1945, e anche perché ne paghiamo le conseguenze. Israele non potrebbe esistere senza di noi in questo momento, e noi gli diamo l’ombrello della difesa.
Li difendiamo nelle loro guerre. Perché mai vorresti che gli Stati Uniti se ne andassero? Beh, perché gli Stati Uniti, pur non facendo un ottimo lavoro nel contenere Israele, hanno comunque avanzato richieste a Israele per molto tempo. È molto fastidioso. Immagina se ricevessimo lo stesso caso comunitario da, non so, Ottawa, e loro dicessero: «non potete fare questo. Non potete fare quello». Diremmo: «vattene a un certo punto. Indietreggia, Canada». Stiamo facendo quello che vogliamo. Siamo una grande potenza. Tu… Devi far uscire gli Stati Uniti.
Questa guerra è progettata per farlo perché gli israeliani, che sono molto ben informati sulla politica interna americana, sanno che non c’è alcuna propensione a fare vittime tra il pubblico americano, che questa guerra non ha avuto nulla che si avvicini al sostegno della maggioranza. In realtà, godeva di un piccolo sostegno minoritario, che si è ridotto anche in 36 ore, e che questo avrebbe causato una crisi politica negli Stati Uniti, e che avrebbe convinto in modo decisivo i nostri alleati arabi nella regione, ovvero gli Stati del Golfo e la Giordania. Povera Giordania, Paese meraviglioso. Li avrebbe convinti che gli Stati Uniti sono un pessimo alleato.
Aiuta Renovatio 21
Perché? Perché nel momento in cui colpisci l’Iran, e i persiani non sono affatto stupidi, sai che colpiranno le basi americane in quei paesi, cosa che hanno fatto, tranne l’Oman. Ma negli altri sei, l’hanno fatto. Sai che quei paesi non saranno difesi dagli Stati Uniti, e non se la passano molto bene. Alcuni di questi paesi sono in fiamme in questo momento, e si sentono completamente vulnerabili, e sono a terra e non lasciano trapelare alcun segreto operativo che non si possa trovare su internet. Hanno una difesa missilistica a corto di energia.
Un Paese come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti o il Qatar, il Bahrein o il Kuwait. Sono tutti sul Golfo, proprio di fronte all’Iran. Vivono della loro produzione energetica, e questa viene danneggiata, e nessuno li protegge. Un impianto della Saudi Aramco è esploso ieri sera. Saudi Aramco è la storica compagnia di produzione energetica congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, la più grande compagnia petrolifera al mondo. E una parte di esso è in fiamme oggi. Gli iraniani hanno detto di non averlo fatto. Perché avrebbero dovuto dire di non averlo fatto? Cosa? Possibile, l’ha fatto Israele. Perché non avrebbe dovuto? Perché, se ci pensi, spaventare i nostri altri alleati nella regione, far loro sapere che possono essere attaccati e che gli Stati Uniti non li difenderanno.
Sopportate tutta questa roba per decenni perché avete truppe americane sul vostro territorio e alla vostra popolazione non piace, ma lo fate comunque perché vi è stato detto che se mai ci fosse un problema, gli Stati Uniti verrebbero a salvarvi. Beh, indovinate cosa abbiamo appena imparato? Gli Stati Uniti non verranno a salvarvi. Ci sono centinaia di migliaia di americani, civili, intrappolati in Medio Oriente. Non può uscire. I governi di quei paesi sono nel panico e sono infuriati. Il messaggio per loro è che gli Stati Uniti non sono un partner affidabile.
Qual è il senso di questa partnership? Che senso ha permettervi di avere una base aerea nel mio paese se quando piovono missili o i droni attaccano il nostro aeroporto, il nostro aeroporto internazionale, non fate nulla al riguardo? È così che la pensano, e potete capire perché lo fanno. Qual è il suo messaggio per loro? Non c’è alcun vantaggio nel trattare con gli Stati Uniti. Non c’è alcun vantaggio negli investimenti esteri negli Stati Uniti. Se vai in uno di questi paesi, vai all’aeroporto, vai al ristorante. Da chi ti rivolgi? Da uomini d’affari americani. Alcuni di loro hanno buone idee.
Alcuni di loro hanno idee così stupide che non potrebbero venderle nella Silicon Valley. Non potrebbero rivolgersi ai venture capitalist negli Stati Uniti e raccogliere fondi. Quindi vanno nel Golfo. Non è che gli arabi del Golfo siano stupidi. In un certo senso, lo fanno perché vedono gli Stati Uniti come il loro unico vero alleato. Quindi investono in iniziative imprenditoriali americane. Molto. Centinaia di miliardi di dollari. E parte di questo è calcolo economico. Pensano che queste aziende cresceranno e faranno soldi. Parte di questo è amicizia. Sei un alleato e lo sei stato per tutti questi anni da quando gli inglesi se ne sono andati.
Cosa ne pensano ora? Beh, non la pensano più così perché per loro, questo è molto… voglio dire, questi paesi non coltivano il proprio cibo. Se chiudi l’aeroporto e il Golfo Persico e il Mar Rosso vengono chiusi, di fatto, dove prendi il cibo? Questo è un vero problema. Si tratta di paesi che, in alcuni casi, si riforniscono di acqua tramite impianti di desalinizzazione, che aspirano l’acqua di mare attraverso una membrana e la convogliano poi nei centri urbani. Cosa succede se questi tubi saltano in aria?
Non hai acqua. Ci sono milioni e milioni di persone. Puoi vedere, senza entrare troppo nei dettagli, quanto vulnerabili si sentano ora questi paesi, i nostri più forti alleati nella regione, e come i loro calcoli sugli Stati Uniti e sulla regione siano cambiati radicalmente. Gli inglesi persero la loro influenza in Medio Oriente nel 1956, in quella che è nota come crisi di Suez. Fu una crisi così complessa che è difficile persino comprenderla ora, 70 anni dopo. Ma l’effetto netto fu che il Regno Unito non fu in grado di ristabilire l’ordine nella regione. Avevano meno potere di quanto la gente pensasse. E questo fu tutto. Quella fu la vera fine dell’impero britannico, e certamente la fine del suo controllo sul Medio Oriente. Ecco cos’è, ed è stato fatto apposta. Lo hanno fatto loro, gli israeliani ci vogliono fuori, e lo hanno fatto apposta. E poi, come ultima nota a piè di pagina, c’è un altro grande perdente in questa guerra, nella guerra di Israele. Questo era ovvio anni fa, ed è l’Europa. L’Europa? A chi importa dell’Europa? Beh, i neoconservatori si preoccupano dell’Europa per ragioni non del tutto chiare. Ma spesso si sentono i neoconservatori, i falchi, i «brividi per Israele», come li si voglia chiamare, ma sono persone che hanno sostenuto quello a cui stiamo assistendo ora.
Sono arrabbiati con gli sciiti, gli eytola e gli arabi, e ovviamente, l’hanno capito. Ma se ascoltate attentamente, c’è una profonda ostilità, un odio, in realtà, verso l’Europa occidentale. Ora, da dove viene tutto questo? Qualcuno dovrebbe rifletterci a fondo, perché ha avuto un impatto enorme negli ultimi 80 anni. Non importa nemmeno da dove provenga. Odiano l’Europa occidentale. Forse la più grande perdente di tutti, l’Europa. Quindi ieri sera, il Qatar ha bloccato le sue esportazioni di GNL. Il GNL è gas naturale liquefatto. Senza voler essere noiosi, il GNL è essenziale per l’economia globale. È essenziale per l’Asia. La Corea del Sud sopravvive grazie alle esportazioni di GNL del Qatar. La Cina ne è un grande consumatore.
E l’Europa occidentale, la Gran Bretagna, il 40% delle case in Gran Bretagna sono alimentate dal GNL del Qatar. Ci sono molte ragioni per questo. Abbiamo fatto saltare in aria il gasdotto Nord Stream, ma non importa. Questa è la verità. Quindi, quando si interrompe l’approvvigionamento di gas naturale dal Qatar, e ora è tutto chiuso, si interrompe il 20% della fornitura mondiale totale. Beh, le conseguenze sono di ogni tipo. Si schiacciano i mercati, si fa impennare l’inflazione, si può creare il caos nell’economia globale.
Preghiamo che non lo faccia, ma potrebbe. Ma la prima cosa che fa è travolgere completamente l’Europa. Poi c’è l’effetto di secondo ordine, la crisi dei rifugiati. Diciamo che questa operazione raggiunga il suo unico vero obiettivo, ovvero decapitare il governo iraniano. Non sembra ancora successo. Voglio dire, chi… Questo è ciò che sta realmente accadendo. Ma l’Atalya è stato ucciso. Il governo continua a inviare missili, quindi qualcuno sta prendendo decisioni. Ma diciamo che nel corso di tutto questo tempo, il caos diventa la situazione attuale in Iran. La situazione crolla. È il caos. È un paese enorme e caotico, senza nessuno al comando e con molti gruppi etnici e gruppi religiosi separati che combattono tra loro, pesantemente armati. Le cose normali iniziano a crollare, come la distribuzione di cibo e acqua, le scuole. Cosa succede? Beh, c’è quello che abbiamo avuto in Libano e Siria.
In realtà, ogni paese che Israele ha destabilizzato di proposito, ha una crisi dei rifugiati. Dove vanno a finire? Beh, certo, molto arriverà qui, certo, ma molto andrà in Europa, proprio come i siriani sbarcarono in Europa 10 o 12 anni fa, in seguito a quel conflitto che, in fondo, era fomentato da Israele per destabilizzare il suo vicino e aumentare la propria autorità nella regione.
È un dato di fatto. Se pensate che l’Europa sia in cattive acque ora, oh, ragazzi, datele un anno. Sono l’Europa, gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo. Sono loro i perdenti. Se state cercando di accertare il movente, il che è difficile, e probabilmente dovreste tirarvi indietro la maggior parte delle volte, ma se state cercando di capire perché questo sta accadendo, perché dovreste volerlo? Guardate gli effetti. Non guardate l’ideologia di cui vi stanno parlando o qualsiasi movente affermino di avere o che voi abbiate. Taci, scemo. Okay. Guardate gli effetti. Il punto del sistema è ciò che fa.
Cosa fa questo sistema, cosa fa questa guerra? Danneggia gli Stati del Golfo, schiaccia gli europei occidentali e danneggia gli Stati Uniti. Questo è il punto. Se ne dubitate, se dubitate che sia davvero quello che sta succedendo, questo è un politico israeliano di lunga data, Neftali Bennett, che spiega il prossimo passo di Israele. Ecco dove stanno andando. Guardate. Sta emergendo una nuova minaccia turca. Voglio essere molto chiaro. La Turchia e il Qatar hanno guadagnato influenza in Siria e stanno cercando di influenzare altrove e ovunque nella regione. Da qui, avverto, la Turchia è il nuovo Iran.
Erdoğan è sofisticato, pericoloso e cerca di accerchiare Israele. Non possiamo più chiudere gli occhi. È sofisticato e pericoloso. Non è certo un’approvazione di Erdoğan o di Erdoğan, il leader turco, non è certo un’approvazione di lui dire: «Quando Bennett dice che è pericoloso, quello che intende veramente è che è sovrano». Non possiamo dirgli cosa fare. Non lo controlliamo completamente. Possiamo influenzarlo. È chiaro che Israele e la Turchia hanno avuto qualche relazione nel rovesciamento di Bushar al-Assad in Siria l’anno scorso, giusto per indovinare. Ma il vero problema con la Turchia è che non può essere controllata. Quindi è una minaccia per Israele. E ancora, non attaccare Israele. È vero.
È vero. Nello stesso senso in cui quando abbiamo leader ostili nei grandi paesi del nostro emisfero, la cosa ci dà davvero fastidio. E a volte li uccidiamo, li sottoponiamo a cambi di regime e inventiamo tutta questa storia: «No, è davvero importante». La gente del Paese X ha bisogno di essere libera. Ma in realtà, abbiamo bisogno di essere senza vincoli perché siamo una grande potenza. Ecco cos’è. È importante dirlo, non per denunciare una qualche oscura cospirazione da parte degli israeliani, ma per spiegare che non è affatto insolito.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
È la cosa più normale al mondo. Ciò che è insolito è vivere in un Paese così controllato, il cui ambiente mediatico è costruito con tanta precisione per impedirti di sapere tutto ciò che conta, di vedere le cose più ovvie, e che è stato costruito come una teoria non cospirazionista, nel corso di molti, molti anni, per impedirti di non sapere. Bari Weiss potrebbe dirigere la CNN. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe successo.
Okay, ora. Ma lo scopo di queste mosse nei media è controllare il modo in cui le cose vengono descritte in modo da non poterle vedere chiaramente e confondere il discorso con l’antisemitismo, i nazisti. No, questa è la classica competizione tra grandi potenze, e noi semplicemente non riusciamo a vederla perché siamo stati così accuratamente propagandati, che pensiamo che si tratti di un tentativo di liberare qualcuno. Non lo è.
Ma allora la domanda diventa: qual è il nostro ruolo in tutto questo? Ora che lo sappiamo, e tra l’altro è pericoloso saperlo, e uno dei motivi per cui quasi non l’ho fatto, non che io stia dicendo qualcosa che non sia ovvio, è tutto molto ovvio, ma dirlo ad alta voce non rende le cose più stabili. In altre parole, una volta che c’è una guerra in corso e tutti sanno che non viene combattuta per conto delle persone che muoiono o delle famiglie che si lasciano alle spalle, allora le cose non diventano più stabili.
Nessuno vuole aggravare l’attuale instabilità. Ma penso sia importante conoscere la verità e sapere cosa hanno pianificato i nostri leader, perché, come già sapete, mentono e non hanno alcuno scrupolo. Ci sono pochissime persone a Washington che hanno meno scrupoli del senatore Tom Cotton dell’Arkansas. Odio dirlo. Lo conosco. Ma questa clip di un programma domenicale, che a quanto pare esiste ancora, la dice lunga su come la pensano e su dove vorrebbero portarci in futuro.
Ora, ovviamente, un rischio di quella campagna è che un aereo possa essere abbattuto, e il Presidente non lascerebbe mai indietro un pilota. Quindi senza dubbio abbiamo risorse di combattimento, ricerca e soccorso nella regione pronte a intervenire e recuperare qualsiasi pilota caduto. Ma a meno di questa insolita circostanza, Margaret, il Presidente non ha in programma alcuna forza di terra su larga scala all’interno dell’Iran. Il Presidente non ha in programma alcuna forza di terra su larga scala in Iran. Oh, davvero? Una forza di terra su piccola scala.
È questo che stai dicendo? Beh, è quello che sta dicendo. Il Segretario alla Guerra è stato intervistato poco fa e ha insistito un po’ su questo, e ha detto: È possibile perché, ovviamente, è possibile. A proposito, non dovresti nemmeno attaccare le persone per aver detto la verità. Dovresti attaccare chi cerca di impedirti di dire la verità. Ciò che ha appena detto il Segretario alla Guerra, Pete Hegset, è, ovviamente, ovviamente vero ed è sempre stato vero. Non c’è una sola persona che capisca una situazione come questa, una guerra cinetica, che pensi di poter influenzare un cambio di regime rispetto all’epoca. Nessuno ci ha mai pensato. Nessuno lo pensa ora. Se si è sinceri nel voler cambiare la leadership di un Paese, per definizione, è necessario impegnarsi.
Beh, certo, non tu, ma qualche ragazzo, qualche uomo più giovane, che sta lottando per la libertà, che deve entrare lì e rischiare la vita per riuscirci. Servono truppe, truppe di terra, soldati sul campo, o qualsiasi stupido eufemismo usino per mettere i giovani americani sulla strada della morte potenziale. E quindi, ovviamente, questo è sempre stato il piano. E vergogna a tutti noi per non averlo detto ad alta voce. Vergogna a tutti noi per essere così intimiditi dai loro incantesimi implacabili, qualunque essi siano. Niente truppe di terra. Il punto non è un cambio di regime. È fermare il loro programma nucleare. Alcuni di noi lo avevano capito, Charlie Kirk lo aveva capito, a giugno. Era una bugia.
Il punto non era che l’Iran non avrebbe mai potuto avere un’arma nucleare. Nessuno vuole che l’Iran abbia un’arma nucleare. Perché Israele ha un’arma nucleare? Perché la Francia ha un’arma nucleare? Nessuno vuole armi nucleari, okay? Nessuno pensa che l’Iran dovrebbe avere un’arma nucleare al di fuori dell’Iran. Ma nessuna persona onesta credeva a giugno, e ora queste persone sono state scagionate, che si trattasse di impedire loro di dotarsi di un’arma nucleare. Si trattava di un cambio di regime, e un cambio di regime richiede truppe di terra, e quindi, se si fa sul serio, si devono avere truppe di terra.
L’unico gruppo escluso da questo calcolo è stato il pubblico americano, che probabilmente non aveva idea, e probabilmente non ha ancora idea, che questa sarebbe stata anche solo una remota considerazione, dato tutto quello che sta succedendo in questo paese in questo momento e data la piccola percentuale, relativamente parlando, di americani che lo volevano, che lo hanno votato, che lo sostengono. I leader di entrambi i partiti lo sostengono. Chuck Schubert lo sostiene con più fervore di Trump. La Msnbc ha appena fatto un lungo servizio su questo, che ho guardato, su questa guerra, ed è colpa degli Stati del Golfo. Sono gli Stati del Golfo, sì. È di nuovo il Qatar. Hanno a malapena menzionato Israele. Sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Sono tutti neoconservatori.
Quando si arriverà al dunque, lo sosterranno. Ma il pubblico non lo sostiene, ed è terribile per gli Stati Uniti. E a proposito, se pensate che sia una buona idea per gli Stati Uniti uscire dal Medio Oriente, il che potrebbe essere, tra l’altro, non è un desiderio folle. Non è questo il modo di procedere. Umiliati dai morti americani, non è questo il modo di uscire dal Medio Oriente. Ma è così che Israele vuole che usciamo dal Medio Oriente.
Non tornerai. Possono rivolgersi al loro nuovo partner, la Cina. E Israele può fornire la tecnologia che livellerà la partita contro la tecnologia cinese che il Pakistan ha usato nel loro ultimo scontro, spaventando la Cina. Hanno capito che abbiamo bisogno di una tecnologia migliore. La Cina è tipo, Oh, sì, abbiamo la tecnologia migliore. È un’alleanza naturale, e ci sono altri motivi per cui è un’alleanza naturale. Ma Israele si sta spostando verso l’India, e gli Stati Uniti, se Israele ottiene ciò che vuole, saranno umiliati e più deboli, gemeranno per i loro morti e saranno molto resistenti a… Ti stai immischiando di nuovo nella politica mediorientale? Vuoi violentare fino all’ultimo bambino a Gaza? Vai avanti.
Vuoi cacciare i palestinesi, i cristiani, dalla Cisgiordania e riempirla di gente di Brooklyn? Vai avanti. Non faremo nulla al riguardo. Questo è l’obiettivo. Quindi, lungo la strada per raggiungere questo obiettivo, degli americani moriranno. Il Dipartimento della Guerra ha affermato di aver confermato che ci sono quattro americani morti. Questo è quello che hanno detto. Non hanno fatto i consueti briefing. Non ci hanno fornito alcuna informazione fino a lunedì pomeriggio, che è la situazione attuale.
Sostieni Renovatio 21
Non ci hanno detto di più. Ma è molto chiaro che tragicamente sono morti di più. Penso che questo sia sconvolgente per le persone nell’amministrazione. Non credo che prendano queste decisioni alla leggera. Credo che molti dei comandanti che hanno mandato quei giovani in guerra avessero sentimenti ambivalenti al riguardo. Voglio dire, sicuramente sì. Quindi non si tratta di attaccare chi ha dato l’ordine perché, ripeto, sono dipendenti che danno ordini. Ma le persone che hanno sostenuto questo, il loro atteggiamento riguardo alla morte di giovani americani, davvero i migliori americani che abbiamo, a favore di una potenza straniera che ci disprezza davvero. C’è qualche altro leader mondiale che disprezza di più gli Stati Uniti di Benjamin Netanyahu? No.
No. Semplicemente non c’è. È puro disprezzo per gli Stati Uniti. E queste persone sono morte per lui? Se stai commentando questo, se stai cercando di capirlo da lontano, devi soffrire per questo. È così ingiusto. È così sbagliato. Eppure, chi lo ha sostenuto non sembra preoccuparsene affatto. Ecco qualcuno che ha sostenuto una guerra contro l’Iran. Non ho intenzione di andare al movente e accusarlo di essere pagato per farlo.
Sarebbe interessante saperlo. Ma Frank Gaffney, che è sempre stato a Washington, tra organizzazioni non profit e think tank… Non c’è posto al mondo dove si rifletta meno di un think tank. Ma fondamentalmente sono organizzazioni di lobbying con esenzione fiscale. Lui fa lobbying per una guerra con l’Iran, non so, da quando ho iniziato a radermi, probabilmente. Ma eccolo qui, ieri, sulla possibilità che gli americani muoiano. Non finirà domani. Prego che finisca, ma non credo che dovremmo aspettarcelo. Ci saranno altre vittime? Piango la perdita di tre militari americani quanto chiunque altro. Ma a questo punto per noi è essenzialmente gratuita. Ci saranno altre perdite? Avete visto il rabbino Waleke parlarne in Israele.
Certo che ci saranno. Se dovessimo operare su basi diverse da questa, probabilmente sarebbe una faticaccia? Una faticaccia. Ma la lotta è di incalcolabile importanza perché se, di fatto, sconfiggessimo definitivamente il suprematismo della Sharia in Iran, ci aiuterebbe in tutti gli altri Paesi. Voglio sottolinearlo non perché Frank Gafney sia la persona peggiore a Washington o perché sia la cosa più folle che qualcuno abbia detto nelle ultime 24 ore, ma perché è perfettamente rappresentativo.
Innanzitutto, c’è il cenno di assenso pro forma al «ci stiamo lamentando, stiamo pregando, mi sto lamentando per le morti». Quando in realtà, quello che si vede in America in questo momento da parte di persone come Frank Gafney è una totale mancanza di rispetto per la morte, un rifiuto di essere riverenti di fronte alla morte, che è sempre e ovunque un segno di rifiuto di essere riverenti di fronte alla vita. Se non riesci ad apprezzare la morte, se non ti inchini davanti a essa in silenzio, sapendo che non capisci appieno cos’è, ma che è più grande di te. Se ti rifiuti di farlo e invece, «sono così contento che sia morto, non importa chi sia».
Se un altro essere umano è morto, e tu non ti fermi a riconoscere che non hai creato quella vita perché non puoi, perché non sei Dio, che c’è qualcosa di misterioso nella morte, qualcosa di più grande di te. Se non lo fai, sei pericoloso. Anche gli animali lo fanno. Hai mai portato il tuo cane dal veterinario e lui non voleva entrare? Perché? Perché il cane sente l’odore della morte. Il cane ha paura della morte. Il cane è in soggezione di fronte alla morte, come dovremmo essere tutti. Ma quasi nessuno a Washington prova questi sentimenti riguardo alla morte.
Cremateli e buttateli via come se non foste mai esistiti. I paesi funzionali piangono i loro morti. Li seppelliscono e vanno a trovarli. Perché? Perché i paesi funzionali capiscono di non avere il controllo della vita perché non hanno quel potere. Chi se ne dimentica è preso da qualcosa chiamata hybris, che è sempre l’inizio della fine per le persone e le civiltà. Oh, sì, è un tris. Piangiamo lì. Stavamo recitando delle preghiere. Davvero? Quali preghiere? Avete recitato una preghiera? Conoscete i loro nomi? Oh, i loro nomi non sono pubblici. Questo potrebbe farci riflettere troppo. Ma nonostante o forse a causa di, e avete appena sentito Gaffney dire questo, senza essere cattivo, senza essere ingiusto. Ha detto: «questo è essenzialmente gratuito per noi».
Davvero? Tre americani sono appena morti per Bibi in una guerra che nessuno vuole, in una guerra progettata per danneggiare gli Stati Uniti, e questo è gratuito? Ed è molto più di tre. Lo dico con vera tristezza. È questo atteggiamento che ci ha portato qui. Ma non resterà così. Sta già cambiando. La cosa che la gente deve ricordare è che la guerra accelera le tendenze in atto. Nulla accelera il cambiamento come la violenza.
Questo vale per i grandi e ampi cambiamenti sociali, le donne nel mondo del lavoro, avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’integrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Voglio dire, nel bene e nel male, giusto? Ma le cose cambiano rapidamente quando le persone iniziano a morire. Non solo a causa dei cambiamenti demografici, perché molte persone muoiono e c’è bisogno che altri prendano il loro posto di lavoro e loro sono all’estero, quindi le donne… No, è più di questo. Uno spirito diverso scende su una società in guerra, e accadono molte cose. Le persone diventano molto meno libere.
Questa è la più grande menzogna di tutte, radicata nella teologia neocon. Stiamo uccidendo queste persone per poter essere liberi. Oh, giusto, no. Trova una guerra in cui le persone in patria siano diventate più libere. Oh, no, è sempre il contrario. La seconda volta che la Gran Bretagna entrò in guerra, cosa fece il governo britannico? A sua volta, la loro opposizione, la loro opposizione interna, con le loro famiglie, con le loro mogli, per tutta la durata della guerra, per anni. Questo accadde in Gran Bretagna, che era, almeno pensavamo, un paese piuttosto libero. Ci diedero la Magna Carta. Sì. No, i paesi non diventano più liberi. Diventano molto meno liberi durante la guerra. Uno spirito di violenza cala, le persone cambiano rapidamente e i calcoli cambiano.
I calcoli politici cambiano molto velocemente. Le tendenze sociali cambiano molto velocemente e gli atteggiamenti delle persone cambiano. E parte di questo non è politico o temporale. È spirituale. Si può percepire nelle persone la sete di sangue, l’odio, e questo accelera. E questo spiega ciò che state osservando in questo momento, ovvero la rabbia dei neoconservatori, il che non ha senso. Non ha alcun senso. Da anni sostengono che il governo degli Stati Uniti, per conto di Israele, debba uccidere Iatola Kamini. Lo dicono da anni. Sono in questo da 35 anni e l’ho sentito ogni singolo anno. L’hanno ottenuto ieri. Kamini è stato ucciso. Ok, hai ottenuto ciò che volevi. È la mattina di Natale. Hai appena aperto il regalo. Perché sei arrabbiato? Sono più arrabbiati che mai.
Questa è la chiave della loro psicologia, ed è un principio spirituale. La sete di sangue non è mai saziata, proprio come qualsiasi altra lussuria. Non è mai sazia. Niente è mai abbastanza. Lo senti sulla lingua e ne vuoi ancora. È come mangiare una caramella. Non ti sazia. Hai sempre più fame. Uccidere è la stessa cosa. Sempre. Ma c’è una psicologia specifica all’opera qui, ed è una psicologia sgraziata e antiumana che non lascia spazio al perdono, alla sportività o alla decenza.
La seconda volta che persone come questa vincono, vogliono uccidere le persone che hanno sconfitto. Immagina che questa sia, non so, una partita di tennis, e tu vinci. Se sei un normale occidentale, ti avvicini alla rete e dici: «bella partita», cercando di dimostrare ciò che tuo padre ti ha inculcato da bambino, ovvero la sportività, ovvero la grazia nella vittoria. Non spadroneggiare su di loro. Non far loro del male. Hai già vinto. Sii elegante. Ciò che vedi nei sostenitori di questa guerra nei Neokind è l’opposto. Batti qualcuno a tennis, salti oltre la rete e lo colpisci a morte con la racchetta.
Questo è ciò che stai vedendo ora. Stai assistendo a questo folle, isterico, di fatto, tentativo di epurare chiunque nel movimento conservatore o nel MAGA, qualunque cosa siano, di epurare chiunque avesse dubbi sulla saggezza di questa guerra, e non solo di epurarlo, ma di screditarlo. Sei un islamista. Molte di queste persone sono sinceri cristiani, che si oppongono a motivi non religiosi. Sei un islamista. Stai prendendo soldi. E ovviamente, è tutta una proiezione. Accusi gli altri di ciò che stai effettivamente facendo tu stesso, ovviamente. Ma è più di questo.
Aiuta Renovatio 21
È sete di sangue. Non dovrebbero essere semplicemente messi a tacere, rimossi dalle piattaforme e impediti di parlare a questa o quella conferenza o di tenere un podcast, ma dovrebbero essere internati. Dovrebbero essere arrestati. Quanto tempo ci vorrà prima che vengano uccisi? Non molto. Questa è la velocità con cui si muovono queste cose. Perché uno spirito è stato scatenato, e la violenza fa questo ogni volta che uno spirito di violenza e odio viene scatenato. Il mio consiglio personale, dopo averci pensato a lungo, è di non alimentarlo.
Questa è chiaramente un’influenza demoniaca. Non è razionale, ovviamente. Perché dovresti essere più arrabbiato quando vinci? Perché dovresti essere più furioso quando ottieni ciò che volevi? Questo ti dice che questo non rientra nel normale desiderio umano. Non lo saresti. Queste persone si nutrono, il male stesso si nutre di odio. Proiettano, ma intendono anche, consapevolmente o meno, ispirare odio perché l’odio li rende più forti. Questo non accade solo in questo Paese, non solo nel 2026. Succede ogni singola volta. La guerra porta alla ribalta persone come queste e le rende più potenti. Ecco perché stiamo assistendo, come negli ultimi anni, a un aumento del vero radicalismo in questo Paese.
Per radicalismo intendo che odiamo queste persone per come sono nate e vogliamo far loro del male o ucciderle. Questo è, credo, un vero radicalismo su cui tutti sarebbero d’accordo. Non è: «hey, che fine ha fatto la USS Liberty?». Non è radicalismo. È come… Questa è la domanda onesta. La risposta, ovviamente, è che Israele l’ha presa di mira di proposito perché eravamo sulla loro strada, proprio come stanno facendo ora. Questo non è radicalismo. Il radicalismo è: «hey, uccidiamo le persone che non ci piacciono». Si sta assistendo a un enorme aumento di questo fenomeno. In questo Paese, in Israele? Ben Gevier o Smotrich sarebbero stati concepibili 20 anni fa? Certo che no. Nessuno del genere aveva potere in Israele 20 anni fa.
Io c’ero. Non era niente del genere. Beh, non è niente del genere perché la guerra ha scatenato tutto questo e ha dato potere alle persone. Abbiamo personaggi come questi in questo Paese, molti dei quali hanno un potere effettivo, non ancora al governo, grazie al cielo. Ma certamente sono alla periferia e certamente influenzano il governo, sì, ce l’hanno. Più potere che mai. È vero, tra l’altro, anche in Iran. Uno dei motivi per cui sarà difficile uscirne è perché questa guerra ha già, dopo un giorno e mezzo dall’inizio, radicalizzato la leadership iraniana al punto che ancora esiste.
Oh, ma non erano già così radicali? Sì, alcuni lo erano, altri no. Un Paese enorme. Molte divisioni e differenze al suo interno. Un Paese molto complicato. Chiunque cerchi di imparare qualcosa sull’Iran o abbia a che fare con gli iraniani ti dirà, a essere onesti, che è complicato, difficile da capire. Quindi sì, c’erano fazioni radicali e fazioni meno radicali. E ora, certo, forse avresti potuto prevederlo se avessi pianificato di uccidere il Papa dell’Islam sciita: gli elementi radicali sono più potenti di prima perché le porte dell’inferno sono state spalancate. Questa è la verità. E chi ha fatto questo sapeva che lo sarebbero stati. E quindi in un momento come questo, con il caos e la violenza che ne sono i tratti distintivi, in un momento come questo, solo i peggiori ne traggono vantaggio.
Questo vale per ogni conflitto come questo, ogni singola volta. Se scoppia il caos in qualsiasi posto, qual è il primo effetto? Il fatto che la polizia, l’esercito, si sciolgono. Non c’è autorità civile. Non c’è autorità legittima. Chi comanda? Quindicenni ubriachi con armi automatiche. Sono loro a comandare. Prendono tutte le decisioni di vita o di morte. Questo accade nei governi, così come negli incroci. È un fatto costante.
Ecco perché si costruisce la civiltà: per proteggere i deboli e per assicurarsi che quindicenni ubriachi e armati non abbiano tutto il potere. È questo il punto. Ma ora ce l’hanno di nuovo. Come possiamo reagire? Dato che sono passate solo 36 ore e non vogliamo che le cose sembrino peggiori di quanto non siano in realtà, potremmo affrontare tutti i numerosi rischi, alcuni dei quali stanno diventando ancora più evidenti di quanto non fossero in passato. Non vogliamo affrontarli tutti. Ma è chiaro che gli Stati Uniti non trarranno beneficio dal rimanere più a lungo in Iran. E mi dispiace, Tom Cotton, mandare truppe sul campo, stivali sul campo, come vuoi chiamarli, mandare giovani americani a morire in Iran non è affatto nel nostro interesse. E non causerebbe solo dolore alle famiglie delle vittime, ma causerebbe anche un potenziale vero e proprio sconvolgimento a livello nazionale e renderebbe fragile un tessuto sociale già fragile. Quindi, cosa faremo ora? Beh, andarcene subito. È così semplice. Certo, è anche incredibilmente complicato. Ma il primo passo è decidere che ce ne andiamo. So che sono passati meno di due giorni, ma è abbastanza chiaro che non otterremo altro.
Come lo sappiamo? Perché nessuno ha spiegato cosa vogliamo guadagnare lì. Nessuno ha descritto la missione. Chiedete a chiunque, qual è il punto di sapere se abbiamo vinto? E alcuni di noi hanno passato 20 anni a chiedersi: cosa stiamo facendo in Afghanistan? Zitti. Siete pro-Talabani? No. Ma vorrei sapere quando abbiamo vinto. Mi dispiace, non potete saperlo. È top secret. Okay. Ma ora è il momento, per essere completamente onesti, non otterremo nulla di più di quanto abbiamo già ottenuto, ammesso che abbiamo ottenuto qualcosa rimanendo. E più a lungo restiamo, maggiore è il rischio.
Quali sono i rischi? Oh, beh. Eccone solo due a cui dovreste prestare attenzione. Uno è che Israele verrà davvero danneggiato. Israele. Nel caso pensiate che questo sia un lungo video che attacca Israele per motivi nazisti o antisemiti, non lo è. È davvero un tentativo di cercare di riflettere su ciò che è bene per gli Stati Uniti. Ma anche, come qualcuno che non vuole fare del male a Israele, a riflettere attentamente su cosa potrebbe essere terribile per Israele. E una cosa che sarebbe terribile per Israele è essere colpiti da un missile ipersonico, che, al momento, l’Iran non ha ancora lanciato.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Potrebbero non farlo mai, ma diciamo che lo facessero. Come reagirebbe Israele, che è un Paese grande quanto il Maryland? Come potrebbe reagire? Beh, potrebbe rispondere con armi nucleari, che ha e che ha minacciato di usare in passato e che ha lasciato intendere di poter usare molte volte. Uno dei motivi per cui non si può lasciare che Israele vada avanti da solo è che insinuano qualcosa tipo: «hey, non farci impazzire e fare qualcosa di folle». Questo includerebbe l’uso di armi nucleari. Non sto dicendo che accadrà, Dio non voglia, ma potrebbe. Se Israele fosse legittimamente minacciato, non performativamente minacciato, ma effettivamente minacciato, come con un missile ipersonico sul centro di Gerusalemme, allora sì, potrebbe. In tal caso, chi lo sa? Perché le armi nucleari non sono state usate dall’agosto del 1945, ma diversi paesi le possiedono, tra cui il Pakistan e forse altri.
E quindi potrebbe arrivare a quel punto. E non vorresti trovarti in una situazione in cui, ancora una volta, come è successo a giugno, ti affidavi alla moderazione iraniana, contando sul fatto che gli iraniani ti chiamassero in Qatar prima di colpire e ti dessero un avvertimento. Non ti piace dirlo, ma se ti trovi in una situazione in cui ti affidi alla moderazione di un Paese che hai descritto come moralmente malato, una nazione terrorista, un Paese nazista, come ti dicono su Fox, se ti affidi al loro comportamento ragionevole, potresti esserti esposto un po’.
Se continua così, potremmo assistere a un’esplosione di caos. Naturalmente, la cosa più assurda di tutte sarebbe uno scontro nucleare, e potrebbe accadere. Non è escluso. Chiedetelo a chiunque si stia occupando di questo o ci stia pensando. Non significa che accadrà, di nuovo, Dio non voglia, ma potrebbe. La possibilità, anche se potesse, è terrificante. Questo è il primo punto. Il secondo è la moschea di al-Aqsa. A Gerusalemme, che a quanto pare fu costruita sul sito del Secondo Tempio. Se siete stati a Gerusalemme, c’è una grande cupola d’oro, un intero complesso. È uno dei luoghi più sacri dell’Islam. Non sono un esperto di Islam, nonostante le numerose accuse, ma lo è. Sembra essere alla pari nell’Islam, da quello che posso dire, con La Mecca e Medina. È una cosa enorme. Dal 1967 è sotto il controllo militare di Israele.
In realtà è controllata legalmente dalla Giordania. Ma è un luogo sacro per ogni musulmano, circa 2 miliardi. Ci sono persone, ebrei ortodossi in Israele, non tutti, alcuni, e alcuni cristiani evangelici in Texas, non tutti, ma alcuni, che vorrebbero vederlo esplodere e sostituito da questo terzo tempio. Non entrerò nella teologia di questo, che è folle e demoniaca, in realtà, ma è un fatto che la gente lo voglia.
Questo è l’inizio, in realtà, della fine del mondo come lo conosciamo, perché ciò darebbe il via a un conflitto religioso. Uccidere l’ayatollah non ti ha portato lì? Ok, fai saltare in aria la moschea e poi ci sarai. Non fa bene a nessuno. Di certo non fa bene agli Stati Uniti. Se continua così, ci sono già persone in Israele, almeno un noto rabbino, che invocano un’azione sotto falsa bandiera contro quella moschea. Falla saltare in aria e dai la colpa agli iraniani.
La verità è che, che gli iraniani la facciano saltare in aria intenzionalmente o in modo improbabile, ma diciamo così, o per errore, o che ci sia un’azione sotto falsa bandiera da parte di Israele, che dà la colpa all’Iran, non importa. Se esplode, non è un problema risolvibile. È la fine di tutto ciò che conosciamo. È un conflitto religioso generazionale duraturo, millenario, finché durerà il mondo, a cui nessuno vuole partecipare. Solo le persone più folli e oscure vogliono farne parte. Questo è l’opposto di ciò che vogliamo, e potrebbe succedere. Il punto è che, una volta che le cose iniziano a diventare folli, potenzialmente possono, anzi, tendono a diventare davvero folli. Quindi, basta con la follia.
Come potremmo influenzare la situazione? Nella misura in cui possiamo, a questo punto, dichiarare vittoria e tornare a casa o ritirarci. È difficile negoziare con gli iraniani. Hanno rifiutato la nostra offerta tre volte. Sì, è vero. L’Iran ha deciso, nella misura in cui decide qualcosa, chissà chi sta effettivamente prendendo le decisioni. Chiaramente, vengono prese a compartimenti stagni, o almeno così sembra. Ma nella misura in cui il governo iraniano può rispondere come un buco coeso, ha risposto: No, non stiamo negoziando con voi. Okay, non può negoziare con loro. Ci fermiamo. Solo misure difensive. Non vogliamo questo. L’economia globale è in gioco. L’ordine globale è in gioco. Le vite americane sono in gioco. Il prestigio americano è certamente in gioco. La nostra capacità di controllare qualsiasi cosa oltre i nostri confini o forse anche al loro interno, siamo fuori. Abbiamo ucciso l’Ayatollah, siamo venuti, l’abbiamo fatto, torniamo a casa.
A questo punto, sarebbe una decisione saggia, e lo è stata. Era molto chiaro fin dall’inizio, qualunque revisionismo la gente voglia aggiungere alla storia, ma era molto chiaro che Donald Trump non voleva una guerra prolungata in Iran, certamente non voleva una guerra prolungata con gli stivali sul terreno, certamente non vuole la guerra che vuole Tom Cotton, ovviamente.
Aiuta Renovatio 21
Stiamo per trasformarlo molto rapidamente in molta sofferenza. Quindi dichiarate vittoria, andatevene. Questa sarebbe la prima mossa. In secondo luogo, a un certo punto, gli Stati Uniti devono tenere Bibi sotto controllo. Mi dispiace, non è antisemitismo. Questo è un capo di Stato le cui decisioni stanno facendo uccidere americani e influenzando la storia del mondo e le sorti, letteralmente, delle fortune, ma anche il futuro degli Stati Uniti. A un certo punto, molto presto, gli Stati Uniti dovranno dire al governo di Israele: «non sei tu il responsabile».
Nessun presidente, come è stato notato dai tempi di John F. Kennedy, è stato disposto a dirlo, ma nessuna amministrazione ha pagato un prezzo più alto per averlo fatto rispetto all’attuale amministrazione. È tragico, a pensarci bene. Certo, non si tratta solo dell’amministrazione, del Presidente e di tutti coloro che lavorano per lui. Si tratta del Paese e delle persone che hanno votato per questo Presidente nella speranza che migliorasse le loro vite. E niente di tutto ciò sarà possibile se continua così. E la colpa, ovviamente, è di chiunque abbia assecondato le richieste, le minacce o altro di Bibi. Ma è colpa loro se hanno assecondato tutto questo.
Ma la causa principale è Bibi e le sue ambizioni. E quindi qualcuno deve immediatamente dire di no. La terza cosa che dobbiamo fare è proteggere gli americani all’estero. Centinaia di migliaia di americani vivono in Medio Oriente. Molti di loro sono bloccati nel Golfo in questo momento, senza entrare troppo nei dettagli. Ma gli americani che vivono o lavorano lì, ovviamente, gli americani in uniforme nelle nostre basi militari, che vengono colpite duramente, non solo nel Golfo, ma anche in Iraq, Giordania e altri luoghi, colpiti duramente, morendo. Ma gli americani che lavorano nelle ambasciate, che sono lì in vacanza, i bambini in vacanza di primavera, che sono bloccati negli aeroporti di Abu Dhabi o Dubai, ce ne sono molti in questo momento, e non possono andarsene.
Con sua grande vergogna, il dipartimento di Stato non ha ordinato l’evacuazione nemmeno dei dipendenti delle ambasciate prima di questi attacchi perché non volevano rivelare quando sarebbero avvenuti. Forse non lo sapevano. Ma tutti noi che osservavamo attentamente sapevamo che qualcosa stava per accadere, e il Dipartimento di Stato non ha incoraggiato queste persone ad andarsene, né le ha aiutate a farlo. Come notato, centinaia di migliaia di americani sono ancora bloccati lì, e in alcuni luoghi non riescono a uscire.
Senza far sembrare la situazione più grave di quanto non sia in realtà, basta sottolineare che in realtà potrebbe essere grave. Questi sono Paesi che dipendono fortemente dalle importazioni di cibo e acqua. Se si chiudono le rotte marittime e gli aeroporti, sono praticamente bloccati. In questo momento, si vedono americani cercare di raggiungere l’Oman, l’unico Paese del Golfo non sotto attacco iraniano, e volare via. Si vedono persone pagare centinaia di migliaia di dollari per andarsene. Quello che non si vede, almeno per ora, è che il Dipartimento di Stato americano si sforzi di dare priorità agli americani.
È possibile a Doha, ad esempio, che i polacchi, i cittadini polacchi, siano assistiti dal loro governo per uscire dal Golfo prima che gli americani lo siano. Non ci sono scuse per questo. Lo scopo del governo degli Stati Uniti è servire gli americani. Lo scopo dei diplomatici statunitensi è servire il Paese che rappresentano e servire gli americani in difficoltà all’estero. Questa situazione è degradante da molto, molto tempo. Se vi è mai capitato di recarvi in un’ambasciata in Messico perché siete stati arrestati per qualcosa, sapete di cosa sto parlando. Ma il punto è che, quando scoppia una guerra scatenata dal vostro Paese, vi aspettate di ricevere aiuto da quel governo, ma non l’hanno ricevuto, ed è scandaloso.
Il fatto che il governo degli Stati Uniti abbia spostato, a quanto pare, una batteria THAAD o un sistema di difesa antimissile dall’Arabia Saudita, dove avrebbe protetto infrastrutture critiche e gli americani, o molti americani in Arabia Saudita, in Israele, non solo danneggia l’Arabia Saudita, un partner fondamentale nel mondo, un partner molto più importante di quanto Israele sia mai stato o sarà mai, danneggia l’Arabia Saudita, ma danneggia anche gli americani. Quanti dipendenti americani del settore energetico vivono in Arabia Saudita? C’è un volo diretto da Riyadh a Houston.
Cos’è questo? Alla base di tutto, al centro, c’è l’obbligo del governo degli Stati Uniti di servire le persone che rappresenta, che lo pagano, in nome delle quali accadono tutte queste cose. Hanno completamente perso di vista questo aspetto. Questo porta a un problema più profondo e tabù, che è un problema reale e i cui frutti stiamo vedendo ora, ovvero che ci sono un sacco di persone nel governo degli Stati Uniti che non antepongono gli Stati Uniti agli interessi di Israele, punto. L’avete visto molto chiaramente con Mike Huckabee. L’abbiamo intervistato la scorsa settimana a Tel Aviv, credo. Non c’era assolutamente la sensazione che rappresentasse gli Stati Uniti o che avesse alcun interesse in ciò che accadeva agli Stati Uniti.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Il suo partito è in difesa di Israele. Ora, Huckabee, grazie al cielo, non è ebreo. È come alcuni, che sanno qual è la loro religione, ma non è ebreo, quindi non si può… Non è antisemita dirlo. È solo un dato di fatto. La lealtà di Mike Huckabee è rivolta a Israele più che agli Stati Uniti, ma non è certo il solo a pensarla così. Come potrebbe esserci nel 2026 una persona con doppia cittadinanza che condivide la cittadinanza con un altro Paese, incluso Israele, ma non solo, con qualsiasi Paese? Come potrebbe esserci una doppia cittadinanza a un alto livello di governo? Non si possono servire due padroni.
Non si può essere leali a due Paesi contemporaneamente. Ecco perché siamo contrari alla poligamia in Occidente, giusto? Ma la permettiamo. Perché? Perché nessuno vuole essere insultato se si oppone. Non si tratta solo di doppia cittadinanza. È una confusione su chi stiamo tutelando. In alcuni casi, è involontario. Nessuno ha specificato le regole. Non è maligno. È solo stupido. Nessuno ha avuto il coraggio di… Ehi, lavori per il governo degli Stati Uniti. Ogni decisione che prendi deve mettere in cima alla lista i cittadini americani. È un bene per la mia nazione o no.
Nessuno si sente mai ripetere quella lezione. Non c’è una cultura del genere. Non è così con questa amministrazione. È così in ogni amministrazione della mia vita. Certamente, dall’11 settembre, abbiamo bisogno di un governo che abbia come obiettivo dichiarato la protezione dei cittadini americani, punto. Se altre nazioni ne traggono beneficio, benissimo. Non siamo contro nessuno. Ma il punto deve essere l’America e servire gli interessi americani. Se un’idea sembra buona, ma danneggerà gli Stati Uniti, siamo contrari.
Questa è la nostra posizione ufficiale come Paese. Se lavori per il governo e non condividi questa visione, non puoi lavorare per il governo. Di certo non puoi prestare servizio in un esercito straniero. Cosa stiamo facendo? È così reale. Tutte queste persone nella vita pubblica hanno prestato servizio nell’esercito israeliano, ma non in quello statunitense. Va bene. Ma a quel punto non puoi avere influenza sul mio Paese. Hai prestato servizio in un esercito straniero e non nel nostro. Nessuno ha voluto parlarne, ma va avanti da molto tempo. Bill Clinton, durante il suo discorso di fine mandato, disse: «orrei aver prestato servizio nell’IDF». Davvero? Ha evitato la leva obbligatoria.
Non è una difesa della guerra del Vietnam, che è stata idiota, ma è una chiara dichiarazione di priorità. Presterò servizio nell’esercito di un Paese straniero prima del mio? Beh, allora non puoi essere al mio comando. Mi scusi, non è un leale americano. Come definiamo la lealtà? Come indossare un’uniforme? Indossare l’uniforme di un esercito straniero e presentarsi al Congresso degli Stati Uniti, sventolando una bandiera straniera al Congresso degli Stati Uniti? Questi sono atti totalmente squalificanti. Il fatto che abbiamo perso la capacità di vedere questo dimostra che siamo stati tutti sotto un incantesimo. Speriamo che ora si rompa, perché non si può continuare con il sistema che abbiamo. Non è un attacco a nessuno.
È lo standard che Israele applicherebbe a se stesso o qualsiasi Paese sovrano applicherebbe a se stesso. Dovete essere dalla nostra parte o non potete lavorare qui. Noi non abbiamo questo. La cosa più sconvolgente, in realtà, è la possibilità di ciò che potrebbe accadere qui. La prossima cosa che dobbiamo fare è prepararci a molti cambiamenti interni. Come ho detto, lo spirito di violenza, di odio, di uccisione si è scatenato. Lo si vede nelle persone. Se leggete i commenti online, lo vedete certamente in evidenza.
La gente è arrabbiata. Ha il sapore del sangue sulla lingua e vuole uccidere. Non lo vuoi qui. Non lo vuoi nel tuo Paese. Questo vanifica il punto. L’unica ragione per cui abbiamo un esercito è garantire la pace e la prosperità negli Stati Uniti. Tutto qui. Se l’azione militare aumenta la povertà e la violenza nel tuo Paese, come sempre accade, è un male. Ora stai assistendo a uno sforzo concertato da parte di persone che agiscono per conto di Benjamin Netanyahu, alcuni cittadini tecnicamente americani, per fomentare il conflitto religioso qui. Odio i musulmani.
Non so bene cosa pensare di Israele, ma abbiamo gli stessi nemici. No. Gli unici nemici che abbiamo sono i nemici degli Stati Uniti, e sappiamo chi sono i nostri nemici da ciò che ci fanno, da come ci trattano, da cosa ci chiedono. E da questo punto di vista, Israele non è un alleato. E non so chi siano questi musulmani di cui stai parlando. Se sei contro l’immigrazione di massa, ovviamente, come si ottiene l’immigrazione di massa? Qualcuno lo sa? L’abbiamo ottenuto dopo… Abbiamo avuto un’immigrazione musulmana di massa dopo l’11 settembre. E le persone che l’hanno spinta, perché ero qui, e lo ricordo molto bene, sono le stesse persone, in alcuni casi, letteralmente le stesse persone, che sora dicono che l’Islam sia il nostro nemico.
Sostieni Renovatio 21
Non è affatto un’approvazione dell’Islam. Come cristiano, non approvo l’Islam. Ma odio mentire perché non è mai casuale. È sempre al servizio di un fine più oscuro. In questo caso, è al servizio del più oscuro di tutti gli scopi, che è quello di dividere questo Paese contro se stesso lungo linee religiose. Eppure la gente si alza in piedi e dice qualcosa che non avresti mai detto 20 anni fa: odiare tutti i musulmani. In che modo questo è meglio di odiare tutti gli ebrei? Faccio una pausa mentre spieghi.
Certo, non possono spiegare perché non è in alcun modo meglio di «odio tutti gli ebrei». È la stessa cosa. Odio tutti i cristiani, se è per questo. Ma stai assistendo a uno sforzo concertato per farlo. Quasi certamente vedrai, come abbiamo visto prima, atti di violenza che potrebbero essere o meno organici, progettati per spostare fortemente l’opinione pubblica in una direzione a beneficio delle persone al di fuori del nostro Paese. È semplicemente un dato di fatto. Se pensi che non sia un fatto, se è una teoria del complotto, se è una teoria del complotto antisemita, oh, stai forse sostenendo che si tratti di una falsa bandiera? Oh, sì. Sono stati ampiamente documentati. Ma c’è un modo per porre fine a questa discussione.
Non c’è bisogno di discuterne. Possiamo declassificarlo. Possiamo conoscere la verità. Possiamo lasciare che la luce del sole, come ha detto il giudice Brandeis, entri, e questo disinfetterà. Perché non lo facciamo? Iniziamo con l’assassinio di Kennedy, 63 anni fa: quei documenti non sono stati declassificati. Perché? Perché ci sono migliaia di documenti relativi all’assassinio di Kennedy che non sono stati declassificati? È un dato di fatto. Nonostante un ordine esecutivo dello scorso gennaio, atti del Congresso in 63 anni… Non lo so. Ora stiamo solo speculando. Scopriamolo. Perché milioni di documenti sull’11 settembre sono ancora classificati? Le stesse persone che ti danno del pazzo per aver speculato sul perché potrebbero essere classificati, pretendono che rimangano classificati.
Non c’è giustificazione per questo. La segretezza favorisce il male. È questo il punto. Non c’è alcuna considerazione di sicurezza nazionale in gioco nei documenti di Kennedy, nei documenti dell’11 settembre. Dico che sono stronzate. Stai mentendo. Quindi finiamola. E a proposito, se si volessero odio, conflitti etnici e teorie del complotto, se si volesse far sì che gli americani diffidassero e si odiassero a vicenda, se si volesse eliminare ogni fiducia nel governo, se si volesse che nessuna autorità avesse legittimità in un Paese, si renderebbe tutto segreto.
Quindi tutti hanno dovuto fare ipotesi su cosa stesse realmente succedendo. Avresti creato una nazione di complottisti. Questo è l’effetto della segretezza di oltre un miliardo di documenti federali. La democrazia è finita. Certo, non si può partecipare in modo significativo a un governo se non si sa cosa sta facendo. Non c’è democrazia con un miliardo di documenti segrete. È finita. È un’oligarchia. Avresti reso la popolazione sospettosa. Li avresti fatti diffidare l’uno dell’altro. Avresti seminato divisione, che è quello che si fa sempre quando si vuole dominare e controllare qualcuno. Li avresti separati gli uni dagli altri. Certo, avresti nascosto i tuoi crimini. Ma c’è un modo per porre fine a tutto questo. L’assassinio di Kennedy, l’11 settembre. Ma cominciamo con il presunto omicidio, i tentativi di assassinio di Donald Trump.
Ora, perché sono significativi? Perché ieri il Presidente degli Stati Uniti ha detto: «ho fatto questo», e con questo intendo dire: ho ucciso il capo di stato dell’Iran, ayatollah Khamenei. Lui mi ha ucciso due volte, ma l’ho preso per primo. È quasi una citazione letterale del Presidente che la pensa così. Gli è stato detto. Capito. Cosa ne sappiamo? Da dove provengono le informazioni che dimostrano che il governo iraniano, guidato dall’ayatollah, questo leader religioso, ha tentato di assassinare il Presidente degli Stati Uniti due volte.
Sappiamo da dove viene? Oh, da Israele. Ecco da dove provengono quelle informazioni. Beh, vediamole. Perché no? A questo punto, è morto. Perché non possiamo vederlo? Oh, fonti e metodi, che peccato. Siamo andati in guerra per questo. Gli americani sono morti per questo. Non ci si può più nascondere dietro a questo. Mostratecelo, e forse ci importerà che ci siano informazioni davvero valide. Dimostrano semplicemente che il governo dell’Iran, guidato dall’Ayatollah, ha cercato di assassinare il Presidente degli Stati Uniti.
Questa potrebbe essere stata una buona ragione per la guerra. Ma forse non lo dimostra, perché questo Paese è stato certamente manipolato molto dall’intelligence israeliana e da quella di altri paesi stranieri, ma certamente dall’intelligence israeliana. Ecco perché pensavamo che ci fossero armi di distruzione di massa in Iraq. Saddam Hussein pagava le famiglie degli attentatori suicidi in Israele, il che è un male. Non lo avallavo. Israele li voleva fuori. Capito. Perché l’abbiamo fatto? Perché l’intelligence israeliana ci ha detto che stava lavorando su armi chimiche e su una bomba atomica. Completamente falso. L’abbiamo saputo dall’intelligence israeliana. A quel punto, la storia suggerisce: «hey, e senza offesa per Ted Cruz o tutti gli altri idioti che dicono sempre: “abbiamo tutte queste informazioni utili”».
Iscriviti al canale Telegram ![]()
È così importante. Ne abbiamo disperatamente bisogno. Davvero, valutiamo la qualità di queste informazioni. Qual è la percentuale vera? Qual è sinceramente sbagliata e quale percentuale è progettata per manipolarci e spingerci ad agire militarmente per loro conto? Sarebbe interessante saperlo. Finché non lo sapremo, il resto di noi si limiterà a fare supposizioni. Alcuni di noi metteranno un freno alla propria immaginazione per cercare di non essere troppo cupi, cercando di immaginare il male dove non ci sono prove, ma altri lasceranno correre la loro immaginazione, e potete capire perché.
Questo avvicina il Paese? No, fa sì che le persone si odino a vicenda. La prossima persona che parla di antisemitismo, la crescente ondata di antisemitismo. Giusto. È reale. È brutto. Totalmente brutto. Come possiamo risolvere il problema? Dobbiamo classificare i file dell’11 settembre. Poi tutte quelle persone su internet hanno detto: Oh, gli israeliani danzanti. L’hanno fatto. Israele aveva quattro conoscenze sull’11 settembre. Erano messaggi di testo inviati a Israele. Un avvertimento dell’11 settembre. Tutto vero, tra l’altro. Cosa significa? Forse niente. Non lo so. Non declassificheranno i file. Mentono al riguardo.
Perché? Dite semplicemente la verità. E a proposito, se ci sono brutte verità in ballo nello scarico di documenti, la gente generalmente riesce a gestirle. Quello che non riesce a gestire è essere mentiti generazionalmente e poi attaccati per aver cercato di capire a cosa corrispondano le omissioni, che è esattamente la situazione attuale. Oggi ci dicono che ci saranno attacchi negli Stati Uniti da parte di cellule dormienti iraniane. Forse. Sembra plausibile. Hanno fatto saltare in aria la nostra base in Bahrein. Hanno colpito il bacino aereo fuori Doha.
Okay. Ci credo. Ma se queste cose accadono davvero negli Stati Uniti, dovremo crederci. Se c’è un dubbio reale, se c’è la sensazione che forse l’FBI abbia effettivamente architettato tutto, non ci stanno dicendo tutto. Se abbiamo la stessa sensazione su quegli attacchi, qualunque essi siano, preghiamo che non accadano, ma su qualunque cosa questi attacchi si rivelino essere, come abbiamo avuto, diciamo, per il 6 gennaio o per l’assassinio di Charlie Kirk. Riuscite a immaginare una cosa più divisiva che possa accadere a questo Paese? Se davvero volessi umiliare l’America, ecco cosa faresti. È essenziale che il governo goda della fiducia dei governati.
Assolutamente essenziale. Non solo moralmente, ma anche operativamente. Non funzionerà senza. E l’unico modo per farlo è dire la verità e denunciare chi mente, ti urla contro, ti insulta. Ti internaremo, ti sbatteremo in prigione. Va bene. Ma prima classifichiamo i fascicoli, e poi potremo calmarci tutti. Che ne dici? Non è solo una provocazione. È sincero. La prossima cosa che dobbiamo fare è tenere sotto controllo le lobby straniere. E non si tratta solo dell’Asia-Pacifico, non si tratta solo di Israele. Sono tante. Sono tante. Il lato negativo dell’immigrazione di massa, ovviamente, è che si possono importare i conflitti e le antiche rivalità etniche di altri popoli nel proprio Paese e poi esserne distrutti.
Questo era ben noto all’inizio del secolo, quando gli Stati Uniti hanno avuto la loro ultima, la seconda più grande ondata di immigrazione di massa, con persone in fuga principalmente dall’Europa orientale. La sensazione era fortemente che questo potesse funzionare. Possiamo usarli per il loro lavoro. In realtà, la popolazione lo odiava. A dire il vero, lo ha sempre odiato, ma a nessuno importa cosa pensano. Ma una classe dirigente più evoluta, altruista e saggia dell’epoca pensò tra sé e sé: «può funzionare».
Stiamo alimentando le nostre fabbriche con la manodopera di cui abbiamo bisogno, ma potremmo anche avere un sacco di guai. Quindi inventiamo questo concetto chiamato «melting pot», dove tutti sono benvenuti. Metteremo una piccola targa sulla Statua della Libertà che spieghi questo concetto, ma tutti devono condividere una cultura e valori comuni. Lasciate alle spalle i vostri antichi rancori, e non importa. Se i vostri antenati hanno ucciso i miei antenati, non ci uccideremo a vicenda. È l’unico modo in cui funzionerà. Avevano assolutamente ragione. Abbiamo abbandonato questa idea, ovviamente, ed era intenzionale. Era un tentativo di dividere il Paese contro se stesso per dominarlo e portare a eventi come quello di oggi. Ma sta accelerando a un punto in cui il Paese non potrà più restare unito se non prendiamo la situazione sotto controllo.
La gente non sembra rendersene conto, o forse sì, ma finge che non stia accadendo. Ma negli ultimi due conflitti, uno dei quali è quello odierno, l’altro quello in Venezuela del 3 gennaio (ma si potrebbero elencare molti altri), c’erano lobby molto attive di esuli provenienti da quei paesi che facevano pressioni sul governo degli Stati Uniti e sul suo esercito affinché rovesciassero la dittatura che avevano abbandonato perché erano pazzi.
Non è una buona ragione per cui il governo degli Stati Uniti debba agire. Le persone che sono qui da un po’ o sono nate qui, i cui antenati hanno combattuto nella Guerra Civile o hanno fondato il Paese, hanno voce in capitolo, e non vogliono avere niente a che fare con questo. Hanno costruito questo Paese, in realtà, e hanno il diritto di dire: «No, se sei arrabbiato, torna indietro e combatti per la libertà di quel Paese, ma ora sei un americano». Ma siamo arrivati a un punto in cui, beh, ecco la CNN di ieri. I persiani a Los Angeles sono davvero entusiasti. A proposito, se mai dovessi incontrare dei persiani a Los Angeles, sono persone fantastiche. Musulmani, ebrei, probabilmente qualche cristiano, ma persone fantastiche. Esilarante, interessante, di grande successo. È divertente stare con loro. Davvero uno dei gruppi di immigrati più divertenti e arricchenti, a dire il vero, avendo avuto a che fare con loro molto spesso.
Sono fantastici. Persone bellissime, anche. Intelligenti. Tuttavia, la loro rabbia verso l’Ayatollah non dovrebbe avere alcun ruolo in ciò che fanno i nostri militari. Non è affatto rilevante. Rendere felice questo specifico gruppo di elettori perché sono stati cacciati da un Paese o perché i loro genitori sono stati cacciati da un Paese. Voglio dire, questo è parlare di «wag the dog». Non è Israele. In questo caso, sono i persiani di Los Angeles, nella zona ovest di Los Angeles, o potrebbero essere i cubani della Florida del Sud, un altro gruppo fantastico, persone fantastiche. Lindsay Graham ha detto ieri: «il prossimo».
Sconvolto dall’arroganza, l’Iran è andato così bene, che rovesceremo il governo cubano… Okay, ora, dopo 65 anni. Ma il punto è che Lindsay Graham è stata portata in delirio dalla lobby cubana, fantastica, super gentile, produttiva, intelligente, attraente, tutto ciò che è fantastico in loro. Nel sud della Florida, molto conservatrice, cristiana. Sono fantastici. Li adoro. Non possono avere il controllo della politica estera americana. Nessun gruppo etnico può avere il controllo della politica estera americana, nemmeno i venezuelani. Quanti immigrati sud-asiatici ci sono ora in questo Paese? Nessuno lo sa. Tantissimi. Che regione lacerata da conflitti etnici.
Ci sei mai stato? Voglio dire, ovviamente ci sono il Pakistan, il Bangladesh e l’India, ma anche l’India stessa. Sono state scritte intere biblioteche su questo argomento. Se dovessi importare questi conflitti nel tuo Paese, saresti il Canada. Oppure c’è un omicidio bengalese, un omicidio di alto profilo, che nessuno nato in Canada capisce. È un incubo. Non è un attacco ai bengalesi, ai punjabi o a chiunque altro. È solo un punto molto ovvio: questi sono Paesi funzionali, l’anglosfera. Sono stati creati da immigrati anglosassoni con un certo sistema, e funzionano.
Tutti vogliono trasferirsi qui perché lavorano. Il modo più veloce per impedirgli di lavorare è importare le cattive abitudini o i rancori secolari della madrepatria. Quindi venite qui, portate la vostra ambizione, la vostra gentilezza, la vostra decenza, il vostro impegno per il progetto americano, ma non portate avanti le vostre attività di lobbying per farci andare in guerra con qualcuno. Non con l’Iran, Cuba, il Venezuela, nessuno. Perché se permettiamo che questo continui, tra 10 anni, combatteremo una guerra in Somalia per conto dello stato somalo del Minnesota o di Portland, del Maine o di qualsiasi altro stato. Se importiamo questa roba qui, questo Paese andrà in pezzi.
Ecco l’ultimo punto, che credo sia necessario sottolineare: questa è una guerra spirituale. Lo sentiamo ripetere spesso. È un termine che circola da, non so, cinque o sei anni, da quando la gente ha iniziato a prestare attenzione e a rendersi conto che non c’è una spiegazione razionale per molte cose che stiamo vedendo. Il transgenderismo o il semplice amore per l’aborto fine a se stesso. Cos’è? Beh, ovviamente, è sacrificio umano. Come per i Maya, gli Inca, i Cananei e ogni altra civiltà, è sacrificio umano. Si uccide un essere umano per placare gli dei e ottenere potere.
È il più antico rituale religioso che esista, e ne stiamo solo assistendo alla sua manifestazione moderna. Le persone hanno più familiarità con questo termine guerra spirituale. Ma le sue manifestazioni non sono sempre così evidenti. Ma se si guarda indietro ai vari momenti della storia, due cose diventano davvero chiare. La prima, in fondo, è rivolta ai cristiani. È rivolta ai cristiani sinceri. Sono sempre loro le vittime principali. Tutti mentono al riguardo. No, la Rivoluzione bolscevica non riguardava davvero il cristianesimo. Davvero? La Rivoluzione francese riguardava davvero il cristianesimo. Perché decapitavano le suore? La Guerra Civile Spagnola, stessa cosa.
La Repubblica Sovietica Ungherese del 1919 durò quattro mesi e mezzo. Qual è la prima cosa che fecero? Giustiziarono tutti i cristiani, il clero, ovviamente. La guerra spirituale può avere un significato un po’ più sottile. In realtà, è Gesù il centro di tutto. Dimostratemi che sbaglio. Chiedetelo a un rumeno. Okay, cosa fate con queste informazioni? Beh, prima di tutto, sappiatelo e basta. Se andiamo in guerra in Iraq con falsi pretesti, e il gruppo che soffre più di qualsiasi altro gruppo, sproporzionatamente più di qualsiasi altro gruppo, si scopre che sono i cristiani che in realtà non stavano alzando le armi contro nessuno, questo dimostra il punto
Se la Siria va a rotoli e i primi a subire un genocidio sono i cristiani, se i cristiani di Betlemme non possono effettivamente percorrere le 12 miglia o giù di lì fino alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme perché, chissà perché, sono loro il bersaglio, ovviamente. Perché l’Europa occidentale viene distrutta? Perché, secondo voi? Perché è lì che si è trasferita Roma, ovviamente, perché è la sede della civiltà cristiana, ovviamente. Certo, certo. Questo è ciò che sta realmente accadendo. Una delle cose di cui hai bisogno per capire questo e combatterlo è una guida spirituale forte e coerente.
Non la leadership militare. In un altro ambito è necessaria, ma nell’ambito spirituale è necessaria una forte leadership spirituale. Ve ne accorgerete quando quella leadership diventerà completamente corrotta, veramente corrotta, quando i leader del cristianesimo o di parti del cristianesimo negli Stati Uniti non saranno semplicemente sbagliati, imperfetti o fuori strada, siamo tutti noi, ma cercheranno attivamente di guidare le persone nella direzione sbagliata. Quando Paula White, che è come una specie di telepredicatrice pazza e totalmente screditata, ordina ai suoi seguaci in chiesa di darle soldi altrimenti non saranno salvati o qualcosa del genere. È come Jimmy Swaggert al femminile.
Quando è a capo dell’Ufficio Fede della Casa Bianca, letteralmente, allora sapete che c’è stato un tentativo concertato di corrompere i vostri leader spirituali in modo che non sappiate cosa sta succedendo. Vedete il caso di Mike Huckabee, un predicatore battista ordinato. Uno dei modi in cui questo accade è sottile e non ovvio per molti cristiani americani, ma è l’approvazione della violenza. Franklin Graham, che è figlio di un grande uomo, ovviamente, uno dei più grandi. Billy Graham era suo padre, consigliere di molti presidenti, grande evangelista, probabilmente il più grande evangelista che questo Paese abbia mai prodotto, Franklin Graham è suo figlio, un evangelista e un operatore umanitario che vola in giro per il mondo, in aereo, portando cibo alla gente, ma considerato un leader cristiano negli Stati Uniti, ha tenuto un sermone, se così si può chiamare, al Pentagono, credo, durante il periodo natalizio, in cui ha descritto il Dio cristiano, e sto citando ora, come un Dio della guerra.
Aiuta Renovatio 21
Noi seguiamo un Dio della guerra. E in realtà non lo facciamo. Non un Dio della guerra fisica, non un Dio che sgancia bombe, ragazzi. Questo non è il Dio cristiano. Questo non è Gesù. E non c’è alcun passo nei Vangeli che lo suggerisca. Anzi, ci sono molti passi che suggeriscono esattamente il contrario. Quindi, se vi trovate in una posizione in cui, come cristiani, cercate di capire la posizione giusta da assumere o lo spirito giusto da avere, il giusto approccio, cosa fate? Vi ritrovate ad ascoltare un leader cristiano che sostiene la violenza contro l’innocenza, sapete, senza attaccarlo. Personalmente, non state ascoltando il messaggio cristiano. Questo non è il Vangelo. È l’opposto del Vangelo.
Eppure è ovunque. L’accettazione negli Stati Uniti da parte dei leader cristiani della violenza contro l’innocenza dovrebbe essere scioccante per le nostre orecchie. Ma abbiamo passato così tanti decenni ad ascoltarla che sembra normale, e non lo è. È un inganno e porterà alla distruzione delle persone, non solo di quelle bombardate, ma anche di quelle che invocano i bombardamenti. Poi, naturalmente, ci sono esempi come John Hagey, uno dei più importanti pastori evangelici degli Stati Uniti, capo di Christians United for Israel, volto del sionismo cristiano, politicamente attivo, grande sostenitore della guerra in cui ci troviamo attualmente, e ancora oggi considerato un leader cristiano.
Ecco John Hagey, nel caso non lo conosceste. Quello che fate a Israele, America, Dio lo farà a noi. Il giorno in cui smetteremo di benedire Israele sarà il giorno in cui Dio smetterà di benedire gli Stati Uniti d’America. Il Congresso degli Stati Uniti deve smettere di discutere ogni anno se inviare o meno assistenza militare a Israele. Dobbiamo continuare a fornire a Israele le capacità specifiche e il supporto di intelligence di cui ha bisogno per colpire e distruggere questi selvaggi una volta per tutte. Dovremmo affondare qualsiasi nave iraniana che minacci il traffico marittimo internazionale. Se non capite appieno quello che ho appena detto, lasciate che ve lo dica in un linguaggio texano.
L’America dovrebbe rimboccarsi le maniche e massacrare Teheran per quello che ha fatto a Israele. Questo non è Frank Gaffney. Questo è un predicatore cristiano. Questo è un uomo che vi dice di proclamare il Vangelo, chiedendo al governo degli Stati Uniti di affondare le navi iraniane e uccidere questi selvaggi. Questo non è cristianesimo, ed è un inganno. È un’eresia, ed è la via verso la distruzione totale, non solo dei nostri corpi, ma anche delle nostre anime. Ieri in chiesa abbiamo ascoltato una lettura, che cercherò di seguire senza lasciarmi trasportare dalle emozioni, che offre, a mio avviso, una via diversa da quella giusta.
Questo fu scritto nel XIX secolo da John Henry Newman. Questa era la Colonna della Pace. Era la Colonna del Giorno nella nostra Chiesa ieri. Mia moglie l’ha scritta per me, e voglio solo leggerla mentre vado via perché penso che questa sia la verità.
«Dio eterno, nel cui regno perfetto non si sguaina nessuna spada se non la spada della giustizia, non si conosce forza se non la forza dell’amore. Diffondi così potentemente il tuo spirito che tutti i popoli possano essere radunati sotto la bandiera del Principe della pace come figli di uno, Padre al quale sia il dominio e la gloria ora e per sempre».
Amen. John Henry Newman, che era sia un sacerdote protestante che cattolico. Questa è la verità. Non si sguaina nessuna spada se non la spada della giustizia. Dio benedica questo Paese. Pregate per questo ogni giorno e torneremo.
Grazie.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Immagine di Gage Skidmore via Wikimedia pubblicata su licenza Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Pensiero
Trump e Bergoglio, figure tragiche

Sostieni Renovatio 21
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Geopolitica
Questa è una guerra mondiale di religione: l’avvertimento di Tucker Carlson

Renovatio 21 pubblica la trascrizione del monologo di Tucker Carlson.
È una scommessa sicura che quasi nessuno coinvolto nella guerra in corso in Iran e nel Golfo vorrebbe che continuasse ancora a lungo. Se si facesse un sondaggio, beh, tra gli iraniani o gli americani, praticamente chiunque, per quanto tempo vorreste che durasse? Pochissime persone direbbero: «Vorrei che durasse a lungo». Ma questo non significa che non durerà molto a lungo, purtroppo è probabile che lo faccia.
È improbabile che si risolva presto. Certo, potrebbe rivelarsi falso. Non si sa mai. È una situazione estremamente dinamica. Ma nel complesso ci sono ancora un paio di questioni irrisolte che questa guerra potrebbe risolvere, questa guerra potrebbe essere l’unica cosa che le risolve e quindi finché non ci sarà un consenso sulle risposte a queste domande, probabilmente continuerà. Quali sono queste domande? Beh, la prima è geopolitica ed è la domanda più importante di tutte: chi governa il mondo, chi prende le decisioni, non semplicemente chi è più ricco, ma chi stabilisce le regole, chi stabilisce i termini. E per la maggior parte della nostra vita, non ci sono stati dubbi al riguardo.
La risposta è stata: gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stabiliscono le regole. Gli Stati Uniti governano il mondo. Questo è vero nella metà occidentale del mondo dal 1945, quando gli Stati Uniti sono emersi più forti e ricchi di qualsiasi altra nazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ed è così dall’agosto del 1991, 35 anni fa, dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Gli Stati Uniti hanno regnato in un mondo unipolare. È così che lo chiamano. C’è un solo polo. C’è un solo centro di gravità. C’è un centro di potere e quello sono gli Stati Uniti. Ma questo è cambiato negli ultimi anni, forse decenni, certamente da quando la Cina è stata ammessa all’OMC nel 2001.
Sostieni Renovatio 21
Ora è un mondo multipolare, avrete sicuramente sentito questa frase e questo significa che ci sono un paio, almeno un paio di centri di gravità, in realtà ce ne sono due. Ci sono gli Stati Uniti e la costellazione di stati con cui sono alleati, e poi c’è l’emisfero orientale del globo. E la Cina ora è alla pari con gli Stati Uniti, almeno, quasi indipendentemente da come la si misuri. La popolazione, ovviamente, è molto più grande. La potenza militare, beh, non ne siamo del tutto sicuri, ma certamente dal punto di vista della produzione tecnologica e industriale, almeno alla pari. E poi, a livello puramente economico, beh, la Cina ha un’economia più grande, un’economia reale più grande degli Stati Uniti. Quindi sì, la Cina è alla pari, e quindi la domanda è, dato che ora ci sono Paesi che sono più o meno alla pari. Pensiamo di non saperlo mai finché non entrano in conflitto, ma sembrano più o meno alla pari.
Chi stabilisce i termini? Commercio, diplomazia e tutto il resto che accade nel mondo. Beh, se si dovesse raggiungere una soluzione diplomatica, ci sarebbe di fatto un accordo di condivisione del potere tra questi due Paesi. Tu prendi l’Oriente, io prendo l’Occidente, ecco i termini. Ma sfortunatamente,Nessun accordo formale o informale è stato raggiunto per una serie di ragioni, la colpa è di tutti, ma una delle ragioni è che quasi nessuno a Washington riesce a comprendere l’attuale, ovvia realtà, ovvero che non siamo più noi a gestire tutto. Siamo in competizione, non necessariamente in conflitto, ma in competizione con quest’altro Paese che è almeno potente quanto noi, la Cina, con un sistema, una lingua, una cultura eccetera diversi, ma almeno ogni aspetto è potente. E quindi non si possono più prendere decisioni unilaterali. È un po’ quel momento che molti genitori affrontano quando sono abituati a dare ordini ai figli. Si rendono conto che il figlio è più alto di loro e, in un certo senso, è come se fosse una nuova relazione. Sei sempre il genitore, ma ormai puoi semplicemente dare ordini.
È più o meno la stessa situazione con la Cina, o forse un po’ più in là. E ciò che abbiamo notato negli ultimi anni è la totale riluttanza, l’inflessibilità dei politici di Washington nel riconoscere la realtà. E invece, proprio mentre parliamo, probabilmente è in corso un simposio a Washington su cosa faremo se la Cina invadesse Taiwan. Beh, certo, dal punto di vista della Cina, Taiwan fa parte della Cina. È solo una specie di fuga negli ultimi 75 anni, ma ne fa ancora parte, questa è la loro visione. E gli Stati Uniti ovviamente non sono in grado di fermare la riconquista di Taiwan, smettiamola di mentire. Eppure solo a Washington questo non è ovvio. Vale a dire che a Washington la gente si comporta ancora come se stesse gestendo tutto senza opposizione, ma non è così. E il resto del mondo sta guardando e pensa, a un certo punto, che bisogna smetterla e affrontare la realtà. Ora ci sono molte persone negli Stati Uniti, me compreso, che vorrebbero vivere in un mondo unipolare. È molto meno divertente essere limitati, dover scendere a patti con un altro Paese prima di prendere una decisione.
Nessuno vuole farlo. Nessuno vuole essere messo in discussione. Ma ripeto, non dipende da noi. O da chiunque altro nel momento in cui vivi. Non sei tu a controllare la realtà, in realtà. E quindi questa è la realtà in cui viviamo, e la domanda è: la affronteremo in modo ragionevole o saremo costretti ad affrontarla con le armi? E purtroppo sembra sempre più probabile la seconda ipotesi. Non è questo il modo di risolvere questioni come questa, perché si può uscire notevolmente indeboliti da queste contese e ritrovarsi in una posizione negoziale molto più debole. Meglio negoziare quando si è forti che quando si è deboli, ma i nostri leader non sono stati abbastanza saggi o lungimiranti per farlo. Presi dall’arroganza, dettavano le condizioni. Era come Baghdad, Bob. È triste in realtà, non c’è motivo di riderci sopra, ma questa è una delle questioni che ora si stanno decidendo in Iran.
Perché l’Iran? Beh, perché queste questioni vengono sempre decise per procura.Nessuna grande potenza vuole entrare in guerra tra loro, ovviamente, soprattutto nell’era nucleare, perché ciò potrebbe significare l’eliminazione simultanea e nessuno lo desidera, almeno consapevolmente. E quindi, in genere queste cose si verificano in paesi terzi, come il Vietnam, notoriamente, o l’Afghanistan sia per i sovietici che per gli Stati Uniti, o la Corea, e ora l’Iran. L’Iran, che fa parte di un’alleanza che include le altre grandi potenze, Russia e Cina. Quindi potrebbero non intervenire esplicitamente, il che significa che non stanno ancora combattendo al fianco degli iraniani. Ma sono certamente dalla parte dell’Iran. E improvvisamente stanno aiutando in una moltitudine di modi prevedibili. E molto per loro dipende dall’esito. E poiché lo fa, rende più difficile risolvere la questione.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
Quindi, questa è la sovrapposizione geopolitica molto ovvia qui. Ecco perché non si tratta solo di un dibattito sul fatto che l’Ayatollah abbia armi nucleari. Basta. È molto più grande di così e molto più grave di così, e le conseguenze sono molto più profonde. Quindi, questa è la prima. Ma c’è un altro livello di cui la maggior parte degli americani non è consapevole, ma di cui gran parte del resto del mondo è ben consapevole. Ed è un livello religioso. Ora, Lindsey Graham è registrato mentre dice a un gruppo di giornalisti, con i suoi occhi iniettati di sangue, il suo viso gonfio, Dio solo sa cosa ha fatto, dicendo esplicitamente: questa è una guerra di religione. Questa è una guerra RELIGIOSA. Ora, il suo motivo nel dire questo, sapete, non è qui per rispondere alla domanda. Possiamo solo fare supposizioni. Sta cercando di fomentare una guerra di religione? Probabilmente. È un tipo da Fine dei Tempi. Ma non importa quasi. Sta dicendo la verità per una volta. Questa è una guerra RELIGIOSA. Fondamentalmente.
Questo non è ovvio per la maggior parte degli americani perché questa è la società più laica, non solo degli Stati Uniti, ma dell’Occidente, del mondo anglofono, dell’Europa e degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda, nella storia. Non c’è mai stata una società più atea, per essere schietti, più laica su larga scala, mai. Non è mai successo niente di simile, mai. Ogni società è fondamentalmente una società religiosa, esplicitamente religiosa, tranne la nostra. Quindi ci mancano i termini per descrivere ciò che vediamo, e ci manca l’immaginazione per pensarci.
E beh, per citare Gesù, abbiamo gli occhi, ma non possiamo vedere. Non vediamo cosa succede intorno a noi, ma il resto del mondo vede molto. Quindi si sente spesso parlare della crisi mediorientale, e di solito si intende l’energia. Sapete, la gente vuole il petrolio, il gas. Ma tradizionalmente, quando si parla di Medio Oriente, si parla di Gerusalemme. Stiamo parlando del luogo più sacro della Terra. Siamo molto più specifici quando parliamo del luogo più sacro della Terra. Il luogo più sacro della Terra è qualcosa chiamato la pietra angolare. La pietra angolare è letteralmente una roccia a Gerusalemme, su quello che un tempo era chiamato Monte Moriah.che un tempo era il luogo più alto nella parte più antica di Gerusalemme. Ed è in quel punto, su quella roccia, sulla pietra che gli ebrei credono che il mondo abbia avuto inizio.
L’Antico Testamento o la Torah ebraica ci dice che Abramo portò Isacco destinato al sacrificio a Dio. È in quel punto che i musulmani credono che il profeta Maometto sia asceso al cielo. E naturalmente è proprio lì vicino che i cristiani credono che Gesù sia stato crocifisso e poi sia salito al cielo. Quindi in quel punto o proprio lì vicino, sono successe molte cose. Ma in modo cruciale in quel luogo, perché fu il luogo in cui Abramo portò Isacco, e di nuovo, alle orecchie degli americani questo suona strano, ma per il resto del mondo è come, sì, tutti lo sanno perché è il centro della loro vita. In quel punto Salomone costruì il suo famoso tempio. Ora, nella Torah, lo dice abbastanza chiaramente, e correggetemi se sto interpretando male, che gli ebrei, seguaci di Dio, possono adorare Dio pubblicamente e sacrificare solo in quel luogo.
In quella città, Gerusalemme, in quel punto. E su quello fu costruito un tempio, il primo tempio. Ora, questo fu distrutto dai Babilonesi, notoriamente. E poi fu ricostruito e in seguito migliorato da Erode. E, al suo completamento, credo fosse l’edificio più grande, certamente il più grande edificio religioso del mondo antico. Fu in quell’edificio che Gesù predicò, in quello che chiamiamo il secondo tempio, il vero centro dell’ebraismo, edificio senza il quale non si può veramente avere un ebraismo basato sulla Torah. La religione semplicemente non poteva funzionare senza di esso, secondo i suoi stessi termini. Nel suo stesso libro, lo affermava. E durante uno dei suoi sermoni, Gesù, che i cristiani credono sia mandato da Dio, dice che questo sarà demolito. Non rimarrà in piedi una sola pietra. E poco dopo fu processato nel cuore della notte e torturato a morte. Guarda caso, questa è la religione.
Ecco la storia. Circa 35 anni dopo, 37 anni dopo, nel 70 d.C., Tito, l’imperatore dell’Impero Romano, entrò in un conflitto piuttosto acceso con gli ebrei della Giudea. Complesso e incredibilmente brutale, ma il punto fondamentale fu che, nel 70 d.C., i Romani assediarono Gerusalemme, sfondarono le mura e strapparono quella pietra del tempio da una pietra all’altra, senza lasciare una sola pietra sull’altra. Davvero una sorta di dedizione alla distruzione che è difficile da immaginare per la mente moderna. Parliamo di genocidio, questo genocidio, che i Romani cercarono di commettere davvero. E riuscirono a distruggere il tempio. E con esso, l’Ebraismo del tempio, l’Ebraismo della Torah, non può avere la religione che esisteva prima del 70 d.C., né dopo il 70 d.C. perché non c’è più un tempio. E quindi questa è una ferita aperta da 2000 anni e certamente comprensibilmente, la gente ha voluto ricostruire il tempio, costruire quello che chiamano il terzo tempio. Ristabilire questa religione nel suo luogo di nascita, ci sono un paio di problemi a riguardo.
Esattamente 500 anni dopo che Tito distrusse il tempio nel 70 d.C., nel 570 d.C.,Un uomo chiamato Muhammad nacque alla Mecca e fondò una delle più grandi religioni del mondo, la seconda religione più grande al mondo, in un periodo di tempo molto breve. Il suo nome era Muhammad. Nacque alla Mecca. Morì nella vicina Medina. Ma nel frattempo, costruì o ispirò la costruzione, entro 50 anni dalla sua morte, di uno dei più grandi monumenti religiosi del mondo, certamente uno dei più belli, chiamato Cupola della Roccia, e si trova a Gerusalemme sul Moriah, costruita sulla prima pietra. E se siete mai stati a Gerusalemme, o se ne avete mai visto delle fotografie, ricorderete vividamente una cupola d’oro. Si chiama Cupola della Roccia.
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Perché si chiama così? Perché c’è una roccia sotto di essa, la prima pietra, che è costruita sul sito del secondo tempio. E quello è quello che è noto come il complesso di al-Aqsa, dove si trova una moschea. La moschea di Galexa, proprio lì accanto, è uno dei tre luoghi sacri, apparentemente luoghi sacri paritari nell’Islam: la Mecca, Medina e la Cupola della Roccia. Quindi, si trova proprio al centro dell’Ebraismo, intendo dire, fisicamente al centro dell’Ebraismo, quel punto, quel punto esatto sopra la prima pietra, e… Ed è stato occupato da una moschea. Una moschea è lì dal VII secolo, dalla fine del 600. Incredibile. Potreste esserne vagamente consapevoli.
Ora, perché dilungarsi su questo? Perché ora è il momento, proprio ora, come questa settimana, è il momento in cui alcune persone, non un gran numero, la maggior parte delle persone, cristiani, ebrei, musulmani, non sono pienamente consapevoli di tutto questo, ma alcune persone ne sono pienamente consapevoli e vorrebbero iniziare il processo di demolizione della Cupola della Roccia, di demolizione della Moschea di Al-Aqsa e di ricostruzione del Terzo Tempio. Ora, ci sarebbero molte cose da dire su questo, sulla sua probabilità, sui suoi potenziali effetti, ma prima, solo una breve nota a margine sulla teologia di questo da un punto di vista cristiano.
Ora, è stato Gesù a dire che questo tempio sarebbe stato demolito, scioccando tutti, a mio avviso, se è nei Vangeli, è almeno in un paio di Vangeli. E le persone che lo hanno sentito non potevano crederci. E naturalmente, le persone che gestivano il tempio, i farisei e i sadducei, ne furono gravemente offesi. Perché non avrebbero dovuto esserlo? Ma poi è successo. Meno di 40 anni dopo, è successo davvero. Aveva ragione, l’ha chiamato lui. E quindi, da una prospettiva cristiana, lo ha fatto. Dio ha chiesto la distruzione del tempio. E come Gesù dice chiaramente nei Vangeli, io sono il tempio ora. Il tempio sarà ricostruito dopo tre giorni. Quando sarò risorto, io sarò il nuovo tempio. Ma negli ultimi 2000 anni c’è stato almeno un tentativo di ricostruire fisicamente un terzo tempio, ed è avvenuto nel IV secolo. E, senza andare troppo lontano, è avvenuto poco dopo la morte di Costantino.
Costantino fu l’imperatore romano del IV secolo che si convertì al cristianesimo e, notoriamente, convertì l’Impero Romano al cristianesimo.Diffondendo così il cristianesimo praticamente all’istante in tutto l’Occidente, dove è rimasto più o meno. Da allora. Questo avvenne nel IV secolo, nel III secolo. Ora, suo nipote divenne imperatore poco dopo la sua morte, e il suo nome era Giuliano, spesso chiamato dagli storici cristiani Giuliano l’Apostata, ed era un apostata. Fu l’ultimo imperatore non cristiano di Roma, dell’Impero Romano. Ed era nato cristiano a quanto pare, ma era un apostata molto aggressivo e si oppose al cristianesimo. E per questo motivo, decise, Giuliano l’Apostata, nel 363 di ricostruire il terzo tempio. Quindi è stato tentato per coloro che si chiedevano: «Potrebbe mai succedere?» Oh, è successo. Hanno provato a ricostruire. Ha speso un sacco di soldi per farlo nel 363. Cosa è successo dopo?
Bene, leggiamo il resoconto dell’unico tentativo mai fatto. Durante la ricostruzione del terzo tempio, e questo proviene da un amico personale di Giuliano l’Apostata che lo scrisse contemporaneamente, e lo conserviamo ancora, sorprendentemente, dopo tutti questi anni. Cito, Giuliano pensò di ricostruire con una spesa esorbitante il superbo tempio di Gerusalemme e affidò questo compito a Olimpia di Antiochia. Olimpia si mise al lavoro con vigore e fu appoggiato da un governatore della provincia. Quando spaventose palle di fuoco scoppiarono vicino alle fondamenta dell’edificio, continuarono i loro attacchi finché gli operai, dopo ripetute bruciature, non riuscirono più ad avvicinarsi. E abbandonò il tentativo. A proposito, solo pochi mesi dopo, Giuliano, l’imperatore Giuliano l’Apostata, fu ucciso. Sapete cosa fu ucciso facendo? Invadendo l’Iran. Letteralmente, invadendo l’Iran nel 363. Sì, fu ucciso facendo quello.
Quindi fu durante la sua invasione dell’Iran che decise di ricostruire il tempio. Non puoi inventarlo e non lo stiamo inventando. E a proposito, ci fu un terremoto nello stesso momento. Ci sono molti resoconti di ciò che accadde quando tentarono di ricostruirlo. E tutti descrivono la terra che si squarcia e le fiamme che ne escono, e tutto sembra un po’ spettrale e soprannaturale. Come se fosse semplicemente perfetto, giusto? Gesù abbatte il tempio e inizia questa nuova relazione con Dio direttamente attraverso di lui.
Non c’è più bisogno di un edificio a Gerusalemme, una città in cui ha fatto di tutto per non passarci la notte, per non camminare fino al Monte degli Ulivi, anche dopo l’Ultima Cena, ma vabbè. E c’è questo tentativo da parte di un tizio che odia il cristianesimo di ricostruire il terzo tempio, e tra l’altro, gli operai vengono bruciati dal fuoco che sgorga dal terreno durante un terremoto.
E puoi riderci su se sei un razionalista, un materialista e un uomo moderno, finché gli archeologi non scoprono che in realtà c’è stato un grande terremoto nella regione, una galea a Gerusalemme nel 363. Quindi è successo davvero. In ogni caso, perché questa lunga lezione di storia? Perché non è più storia. Sta accadendo proprio ora. Ci sono attori chiave coinvolti in questa guerra, quella che sta accadendo stasera.che credono che ciò che vediamo sui nostri schermi televisivi e su Twitter inaugurerà una serie di eventi che iniziano con la distruzione della Cupola della Roccia, della Moschea di Aksa, e poi la ricostruzione del Terzo Tempio, dopo di che il mondo finirà. Dio tornerà. E con loro intendiamo letteralmente alcuni di coloro che combattono la guerra.
Quindi potreste aver letto oggi resoconti secondo cui i comandanti sul campo delle truppe americane, molti di loro, e chissà se questo è vero, ma è là fuori, hanno detto alle loro truppe alla vigilia dello scoppio di questa guerra che stavano facendo questo per Gesù perché è volontà di Gesù che facciamo questo e che facendolo saremo in una serie di eventi che porteranno alla fine della storia, alla fine dei tempi, ad Armageddon, agli ultimi giorni. È difficile credere che sia vero, soprattutto perché, tra l’altro, ci sono un milione di cristiani in Iran.
Quindi, se lo stessi facendo per Gesù, presumibilmente faresti di tutto per non ferire i suoi seguaci nel paese che stai attaccando. Il governo degli Stati Uniti o qualsiasi altro governo ha fatto qualche tentativo di risparmiare i cristiani? Ci stiamo provando stasera? Certo che no. E naturalmente, quando la nebbia si sarà diradata, scopriremo, giusto per indovinare, che i cristiani hanno sofferto in modo sproporzionato in questa, come in tutte le guerre, dalla guerra in Iraq al bombardamento di Nagasaki, la sede della chiesa cristiana in Giappone, eccetera, eccetera. I cristiani hanno un modo di morire in modo sproporzionato in queste guerre, il che la dice lunga sulle loro vere motivazioni. Ma in ogni caso, circolava una serie di storie che suggerivano che i comandanti statunitensi avessero detto alle loro truppe che lo stavano facendo per qualcuno. Strana ragione anticristiana spacciata per cristianesimo.
Aiuta Renovatio 21
Ma non riguarda solo la parte statunitense. Ecco un soldato dell’IDF, apparentemente americano a giudicare dal suo accento, che descrive il motivo per cui è in guerra. Guardate questo.Quando il fumo si sarà diradato, alla fine, scopriremo, giusto per intuire, che i cristiani hanno sofferto in modo sproporzionato in questa guerra, come in tutte le altre, dalla guerra in Iraq al bombardamento di Nagasaki, sede della chiesa cristiana in Giappone, eccetera, eccetera. I cristiani hanno un modo di morire in modo sproporzionato in queste guerre, il che la dice lunga sulle loro vere motivazioni. Ma in ogni caso, circolavano una serie di storie che suggerivano che i comandanti statunitensi avessero detto alle loro truppe che lo stavano facendo per qualcuno. Una strana ragione anticristiana spacciata per cristianesimo. Ma non riguarda solo la parte statunitense.
Ecco un soldato dell’IDF, apparentemente americano a giudicare dal suo accento, che descrive il motivo per cui è in guerra. Guardate questo.Quando il fumo si sarà diradato, alla fine, scopriremo, giusto per intuire, che i cristiani hanno sofferto in modo sproporzionato in questa guerra, come in tutte le altre, dalla guerra in Iraq al bombardamento di Nagasaki, sede della chiesa cristiana in Giappone, eccetera, eccetera. I cristiani hanno un modo di morire in modo sproporzionato in queste guerre, il che la dice lunga sulle loro vere motivazioni. Ma in ogni caso, circolavano una serie di storie che suggerivano che i comandanti statunitensi avessero detto alle loro truppe che lo stavano facendo per qualcuno. Una strana ragione anticristiana spacciata per cristianesimo. Ma non riguarda solo la parte statunitense. Ecco un soldato dell’IDF, apparentemente americano a giudicare dal suo accento, che descrive il motivo per cui è in guerra. Guardate questo.
🇺🇸 🇮🇱 There is a video of an American in service of the IDF that states he is fighting for the near-future construction of the Third Temple.
🔶️ He carries with him the Chabad Mashiach Flag Patch. Previously, our friends at Bellum Acta have stated that this is the flag of the… pic.twitter.com/uDL6qJHCoM
— dana (@dana916) January 20, 2024
Sostieni Renovatio 21
Probabilmente lo sto pronunciando male. È il termine ebraico per tempio, il Terzo Tempio. Lo stiamo facendo per ricostruire il tempio. Ora noterete che sta togliendo delle toppe con il velcro dalla sua uniforme delle IDF. Questi non sono abiti civili. Questa è l’uniforme del governo di Israele, del suo esercito. E ha delle toppe su quell’uniforme, una delle quali è un simbolo del tempio, il Terzo Tempio. Quindi non potrebbe essere più chiaro.
Perché lo stiamo facendo? Per ricostruire il Terzo Tempio. Ora, se pensate che stiamo solo… prendendo spunto da internet, un tizio che indossa una toppa del tempio non autorizzata ha pagato, tra l’altro, un’uniforme pagata da noi, armamenti pagati da noi. Il contribuente statunitense paga per tutte queste cose in un modo o nell’altro. Il contribuente statunitense paga, per l’esercito di Israele, cavolo. Se pensate che siamo ingiusti e ne abbiamo trovato uno… Beh, ecco un gruppo di tizi. Ci sono voluti circa due minuti su internet per trovare questo oggi. Ecco una selezione di soldati dell’IDF. Mettiamola sullo schermo. E tutti hanno lo stesso passato. Guardatemi, guardatelo attentamente. Cos’è? Quello è il tempio. Quello è il Terzo Tempio.
Un minuto dopo l’altro, su come questo potrebbe effettivamente accadere e cosa significherebbe per il resto del mondo. E giusto per essere chiari, queste sono conversazioni che la maggior parte degli americani, me compreso, non ha mai voluto avere. Le convinzioni religiose di tutti, le convinzioni religiose sincere, se esposte alla luce del mondo razionale, del mondo creato dall’uomo, sembrano un po’ inquietanti e folli, il che è uno dei motivi per cui nella cultura in cui alcuni di noi sono cresciuti, non ne parliamo in pubblico. Sono personali. Sono la parte più intima di una persona.
Quindi, a proposito, è senza giudizio che stiamo trasmettendo questo. Lo descriviamo solo perché è significativo per il futuro del mondo, per le caratteristiche di questa guerra e per il nostro futuro come americani. Quindi, come hanno fatto esattamente le IDF, le Forze di Difesa Israeliane, un esercito pagato dai contribuenti americani, a cui molti ricchi americani inviano denaro, agli amici delle IDS, come hanno fatto tutti questi ragazzi a finire con delle toppe che suggeriscono che lo scopo di questa guerra fosse la distruzione di uno dei luoghi più sacri dell’Islam e la ricostruzione di un tempio che è totalmente anatema per il cristianesimo, come è successo?
Beh, ci sono molti modi in cui è successo, il modo principale è successo perché nessuno negli Stati Uniti se n’è accorto perché è un luogo così laico e, come notato, abbiamo gli occhi, ma non possiamo vedere, nelle orecchie e non possiamo sentire, ma questo va avanti da molto tempo in pubblico, in parte grazie agli sforzi di un gruppo chiamato Chabad. E potresti conoscere persone che danno soldi ad Chabado corrono ad Chabad, persone super gentili, impegnate in ogni tipo di attività di beneficenza, centri di recupero dalla droga, sai, c’è molto di Chabad che è davvero buono. Ma cos’è esattamente Chabad?
Bene, Chabad, puoi cercarlo, è un’organizzazione molto antica, circa 250 anni,ed è una branca dell’ebraismo chassidico. È un’organizzazione che è stata supervisionata per molti anni da un certo Rabbino Menachem Schneerson, notoriamente di Brooklyn, considerato il Messia da alcuni dei suoi seguaci. Che era amico di presidenti o certamente qualcuno che i presidenti visitavano. Era un uomo molto potente nella comunità ortodossa e chassidica, ed era il supervisore di Chabad, che lo precedeva e gli sopravviveva, ma ne era l’ambasciatore più in vista. E Chabad ha spinto in modo piuttosto sottile, a meno che non si guardi attentamente, per la ricostruzione del Terzo Tempio.
E sembra, dalle letture che abbiamo fatto di recente, che quelle toppe provengano in realtà da Chabad. In ogni caso, Chabad sta spingendo per la costruzione del Terzo Tempio. Ma non si tratta solo di gruppi chassidici di Brooklyn, e non si tratta solo di soldati dell’IDF. Ci sono sorprendentemente molti leader evangelici americani, cristiani sionisti, il cui obiettivo principale è la ricostruzione del Terzo Tempio.
Ora, come potrebbe un cristiano americano o qualsiasi cristiano invocare la costruzione di un tempio? La cui presenza, la cui presenza intrinseca nega… Detto chiaramente, e i cristiani ci credono, è un punto fondamentale della fede: io sono il tempio. Se vuoi parlare a Dio, parli attraverso di me. Questo è il cristianesimo, questa è l’intera religione. Quindi, se sei un predicatore cristiano che invoca la ricostruzione del Terzo Tempio, in un certo senso hai perso il punto.
Sostieni Renovatio 21
Questa è più che apostasia, è come non sapere nemmeno di cosa tratta la religione. Quindi è difficile credere che possano esserci leader cristiani ordinati che spingono per la ricostruzione del Terzo Tempio. Oh, ma ce ne sono molti. Sono molti. Ed eccone solo uno, questo è il pastore Greg Locke. Ascoltate questo.Se vuoi parlare a Dio, parli attraverso di me. Questo è il cristianesimo, questa è l’intera religione. Quindi, se sei un predicatore cristiano che invoca la ricostruzione del Terzo Tempio, in un certo senso hai perso il punto. Questa è più che apostasia, è come non sapere nemmeno di cosa tratta la religione.
Quindi è difficile credere che possano esserci leader cristiani ordinati che spingono per la ricostruzione del Terzo Tempio. Oh, ma ce ne sono molti. Sono molti. Ed eccone solo uno, questo è il pastore Greg Locke. Ascolta questo.Se vuoi parlare a Dio, parli attraverso di me. Questo è il cristianesimo, questa è l’intera religione. Quindi, se sei un predicatore cristiano che invoca la ricostruzione del Terzo Tempio, in un certo senso hai perso il punto. Questa è più che apostasia, è come non sapere nemmeno di cosa tratta la religione. Quindi è difficile credere che possano esserci leader cristiani ordinati che spingono per la ricostruzione del Terzo Tempio. Oh, ma ce ne sono molti. Sono molti. Ed eccone solo uno, questo è il pastore Greg Locke. Ascolta questo.
Christian Zionist Pastor Greg Locke calls for Israel to genocide Gaza & “get a great big missile and blow that wicked Dome of the Rock plum off the spot where it’s standing right now so we can get that Third Temple rebuilt and usher in the coming of Jesus”pic.twitter.com/BJylGJnwgJ
— Dan Cohen (@dancohen3000) November 17, 2023
Sostieni Renovatio 21
«La Striscia di Gaza, che ora è stata isolata da Israele, e giustamente. Avrebbero dovuto isolarla molto tempo fa. Non mi interessa quanto pensiate che io sia insensibile a riguardo. Ci sono sei porte in questa chiesa. Potete andarvene quando volete. Le hanno tagliate, sapete, l’elettricità, hanno tagliato l’acqua, avrebbero dovuto. Ora ascoltate, non sono per fare del male a nessuno che sia innocente, ma chiunque sostenga il terrorismo non è innocente. Capite? Israele dovrebbe trasformare la Striscia di Gaza in un parcheggio entro la prossima settimana. Distruggere tutto. Quello che dovrebbero fare è evacuare lassù sulla collina e prendere un grosso missile e far saltare in aria quella malvagia Cupola della Roccia dal punto in cui si trova ora. Così possiamo ricostruire quel terzo tempio e questo è l’arrivo di Gesù».
Ragazzi, è imbarazzante e vergognoso per un cristiano americano sentire queste cose e sapere che quel video risale a qualche anno fa. Era su internet. Nessuno si è preso la briga di segnalarlo. La maggior parte delle persone non sapeva nemmeno che stesse succedendo. Oh, sta succedendo davvero, queste sono opinioni molto comuni. Sembra ovvio che Mike Huckabee le abbia, che molti sionisti cristiani, John Hagee, la pensino come Israele? A loro piace molto Israele.
Sono chierici, quindi le loro vite sono state influenzate dalle loro opinioni religiose. Quali sono le loro opinioni religiose? Beh, l’avete appena sentito dal pastore Locke, che è un sionista cristiano piuttosto in vista. Non è un pazzo solitario. Ed eccolo lì con una bandiera israeliana che sventola dietro di lui, che invoca distrattamente la violenza genocida. Fatela saltare in aria, trasformatela in un parcheggio. Beh, ci vivono due milioni di persone. Cosa succede loro? Sono simpatizzanti del terrorismo. Questo è il punto.
Questo non è cristianesimo. Immaginate Gesù che dice: «Uccideteli tutti e basta. Sono terroristi». C’è qualcosa nel Vangelo che suggerisca che Gesù credesse in questo? No, c’è molto da suggerire, anzi, da dirci in termini molto chiari. Lui pensava il contrario. Ma l’ultima parte, “Costruiamo il terzo tempio e portiamo a compimento il ritorno di Gesù”, è una contraddizione diretta con la teologia cristiana fondamentale. E anche chi non ha una laurea in teologia e non ha frequentato qualche prestigiosa scuola biblica può dirvi cosa? Gesù dice: «Io sono il tempio”» Questo non è cristianesimo. Non è nemmeno una sua copia fedele. È chiaramente malvagio.
Ed è, in un certo senso, la forza trainante dietro gli sforzi per ricostruire il Terzo Tempio. Giuliano l’Apostata, che fu l’ultimo a provarci, che morì invadendo l’Iran, non era ebreo. Era un pagano, proprio come il pastore Locke. Ma per qualche ragione, fu lo strumento per tentare di farlo. Ce ne sono molti! Di queste persone, e non solo in ambito teologico, ma anche in ambito politico. E questo è rilevante per voi, che crediate in Dio o no, o che siate interessati alla storia delle religioni abramitiche o no. I leader mondiali credono in questo. Persone che non vi aspettereste, e vi chiedete: cosa sta succedendo qui? È abbastanza da farvi rizzare i capelli.
Tutti sapevano che c’era stato un tentativo di ricostruire il terzo tempio e le fondamenta? Tranne me? Non posso credere di essere stato escluso da questa conversazione. No, tutti noi abbiamo avuto luogo in pubblico. E se avessimo prestato attenzione o fossimo stati sintonizzati su quella frequenza, la frequenza spirituale, se fossimo stati spiritualmente abbastanza sensibili da prestare attenzione, lo avremmo saputo. Ma naturalmente, quando si cresce in una cultura materialista, quando le uniche cose in cui si crede siano reali sono quelle che possono essere misurate o acquistate su Amazon, si tende a perdersi molto.
E a noi è sfuggito questo. Ecco il presidente dell’Argentina, Javier Milei, che conosciamo personalmente, al Muro Occidentale,che alcuni ritengono essere un residuo del Secondo Tempio, l’ultima pietra del Secondo Tempio, questa è l’affermazione. Eccolo lì, il famoso Muro del Pianto, che dice questo, guardate i sottotitoli.
Javier Milei pidió por la reconstrucción del Tercer Templo de Jerusalén, como paso previo a la venida del “Mesías” hebreo. Eso implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los tres lugares más sagrados para más de 1500 millones de musulmanes en el mundo. pic.twitter.com/uzApmzyTbE
— KontraInfo (@KontraInfo) February 9, 2024
«C’è una profezia sulla distruzione che dice che una volpe irromperà nel sancta sanctorum. C’è un’altra profezia che dice che lo stesso posto sarà ricostruito. Ora che vedo con i miei occhi come si avvera la prima profezia. Ora che vedo. Con i miei occhi, la prima profezia si avvera. Rido di gioia e pieno di speranza, perché la seconda profezia si avvererà sicuramente».
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Quindi, una correzione. Quello non sembra essere il Muro Occidentale, e non c’erano sottotitoli. L’hai sentito dire tramite il suo traduttore. Rido e tremo di gioia quando penso alla ricostruzione del Terzo Tempio. Ora, questo è il presunto, forse, chissà, presidente cattolico di un paese a stragrande maggioranza cattolica, un paese sudamericano, un paese meraviglioso, l’Argentina, che è stato eletto ed è stato presentato ai consumatori di notizie americani come un economista libertario che risolverà il problema del debito, eliminerà l’inflazione e renderà la vita migliore per gli argentini. Ed eccolo lì a Gerusalemme che dice di piangere di gioia pensando al ritorno, alla ricostruzione del Terzo Tempio
Che diavolo è? Penseresti che non sarebbe nemmeno nella sua lista di cose da fare se stai governando un paese complesso e danneggiato come l’Argentina e promettente e grande come l’Argentina, ma ci sono un sacco di cose che devi fare in Argentina se la governi. Ma ti prendi del tempo per combattere in Israele e dici: «La cosa che vuoi veramente nella vita è la ricostruzione del Terzo Tempio?». Cosa sta succedendo? E perché non ne abbiamo parlato prima? Diciamo, prima di invadere l’Iran con truppe che affermano ad alta voce: «Stiamo facendo questo per realizzare la creazione del Terzo Tempio». Perché non siamo stati informati?
Ecco un video che potresti aver visto, e che personalmente non voglio far vedere perché conosco quell’uomo e mi piace, ma ti fa riflettere. Quindi questo è l’attuale Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, ex dipendente di Fox News. Brava persona. Bravissima persona. 2018 a Gerusalemme, e conoscendolo bene, posso dirti che non avevo idea che avesse opinioni così evolute, specifiche e apparentemente molto informate sulla ricostruzione del Terzo Tempio, tra tutte le questioni.
Questa non è una cosa che ti insegnano alla scuola domenicale della Chiesa Presbiteriana. È qualcosa di cui si parla a cena negli Stati Uniti. Non è qualcosa di cui il nostro Congresso abbia mai parlato, di cui il Presidente abbia mai parlato. È considerato così esoterico, strano, cripto-storico, religioso, una specie di setta e un male, e nessuno ne parla mai. Ma ecco Pete Hegseth, giocatore di football di Princeton, che ne parla in un modo che lascia intendere che ci abbia pensato a lungo. Siamo nel 2018.
Pete Hegseth was picked as DOW with a VERY specific purpose.
To help pave the way for building of the Third Temple in Jerusalem, by way of the Greater Israel expansion project, by using the American Military Industrial Complex. pic.twitter.com/b8Ie9tg5n3
— The Patriot Voice (@TPV_John) January 28, 2026
«Oggi, Jennifer e io abbiamo avuto l’opportunità di visitare il Muro Occidentale del Monte del Tempio. I tunnel del Muro Occidentale, gran parte della città vecchia. E mentre siete lì, non potete fare a meno di contemplare il miracolo che avete davanti. E mi ha fatto pensare a un altro miracolo che spero non vediate troppo lontano. Perché il 1917 è stato un miracolo. Il 1948 è stato un miracolo. Il 1967 è stato un miracolo. Il 2017, la dichiarazione di Gerusalemme come capitale, è stato un miracolo, e non c’è motivo per cui il miracolo della rifondazione del tempio sul Monte del Tempio non sia possibile. Non so come potrebbe accadere, non sapete come potrebbe accadere, ma so che potrebbe accadere».
Iscriviti al canale Telegram ![]()
Cos’è? È il Segretario alla Guerra in questo momento, che supervisiona la guerra con l’Iran, e che le persone che la combattono stanno iniziando a dire riguarda in realtà la ricostruzione di questo terzo tempio. È lo stesso uomo. Ok, questo è il punto in cui inizi a pensare: forse avremmo dovuto parlare di questo e delle sue implicazioni. E quali sono le implicazioni? Guerra di religione? Guerra di religione?
La prima mossa ampiamente pubblicizzata dell’esercito statunitense e di quello israeliano in questo conflitto è stata quella di uccidere il capo di stato dell’Iran, l’86enne aiatollà. Sostituito oggi da suo figlio, che a quanto pare è più anti-occidentale di lui, quindi immagino che, a rigor di termini, non sia stato molto efficace. Ma se fai tre passi indietro, e nessuno lo ha fatto perché tutti sono impegnati a denunciarlo come Hitler e l’uomo più malvagio del mondo e siamo così grati che sia morto, quando è stata l’ultima volta che l’esercito statunitense o quello israeliano, lavorando in collaborazione con l’esercito israeliano, hanno ucciso il capo di una religione mondiale? È saggio? Non è perché siamo d’accordo con tutte le religioni del mondo, non è un’approvazione dell’Islam sciita dire che forse dovremmo fermarci un attimo prima di uccidere il suo leader 86enne. È piuttosto un riconoscimento che ciò potrebbe avere conseguenze che riguardano gli Stati Uniti, l’Europa e il mondo, ma in particolare gli Stati Uniti, dato che siamo gli Stati Uniti e abbiamo figli e speriamo di avere nipoti, e quali saranno le conseguenze a valle per loro? Quando si uccide un leader religioso.
Uccidere il leader religioso ha paralizzato la loro struttura di comando e controllo? Non erano in grado di lanciare missili e droni quando abbiamo ucciso l’aiatollà 86enne? No. Perché sapeva che sarebbe stato ucciso. È per questo che è rimasto in superficie, a quanto pare. Voleva essere martirizzato. Ora, perché avrebbe voluto essere martirizzato? Forse perché voleva una guerra di religione. Perché lo abbiamo ucciso? Forse perché volevamo una guerra di religione. Ora, perché avremmo voluto una cosa del genere? Perché gli israeliani che ci hanno trascinato in questa guerra, tutti lo ammettono ora, scusate, perché avrebbero voluto una cosa del genere? Non lo so. Pensate a cosa succederebbe se questa guerra portasse alla distruzione della Cupola della Roccia e del complesso di Al-Aqsa sul Monte Moriah a Gerusalemme. E spiegheremo tra un attimo come potrebbe accadere.
Una guerra iniziata con l’uccisione del capo dell’Islam sciita. Cosa succederebbe? Beh, ecco i numeri. Ci sono circa 15 milioni e mezzo di ebrei nel mondo in totale. Ci sono 2,5 miliardi di cristiani e circa 2 miliardi di musulmani. Quindi, qualunque cosa accada in seguito, non sarà una lotta tra musulmani ed ebrei, perché 2 miliardi contro 15 milioni, non è una vera lotta. Probabilmente, se non viene posta immediatamente sotto controllo, o forse è troppo tardi, diventerà una guerra, una guerra di religione, quella che Lindsey Graham ha appena descritto, tra musulmani e cristiani.
E non si svolgerà in Medio Oriente perché si tratta di un conflitto regionale.Ma come notato all’inizio, si tratta di un conflitto globale in cui ogni grande potenza ha un interesse in ciò che accade. Questo si svolgerà a livello globale e si svolgerà nelle nostre città. L’Islam è la religione in più rapida crescita negli Stati Uniti. Non ci sono molti musulmani negli Stati Uniti. Cosa, cinque milioni o qualcosa del genere? Ma è la religione in più rapida crescita. Questo è sufficiente a causare problemi. Di sicuro, in Europa, 65 milioni di musulmani, la seconda religione più grande in ogni paese europeo, in più rapida crescita in ogni paese. In Australia, stessa cosa. Seconda più grande, in più rapida crescita. Nuova Zelanda, stessa cosa. Seconda più grande, in più rapida crescita, Canada, stessa cosa. Cosa succede in tutti quei paesi?
Quei Paesi cristiani, occidentali, bianchi. Cosa succede lì? Se c’è la guerra di religione che Lindsey Graham e chiaramente il governo israeliano e alcuni nel nostro governo sperano, cosa succede? Quei paesi soffrono più di quanto abbiano sofferto. E quindi è possibile che il vero obiettivo qui, è semplicemente possibile, è stato lanciato lì, non siano i mullah in Iran, siamo noi. Come è sempre stato. Ma non fidatevi solo della nostra parola. Ecco una clip particolarmente sincera e sinceramente articolata di un paio di anni fa. È dell’agosto 2024 e proviene da un rabbino israeliano, Joseph Misrach, che descrive come Israele dovrebbe approfittare di un conflitto in corso con l’Iran, molto meno intenso dell’attuale conflitto con l’Iran, per distruggere… la Cupola della Roccia e Al-Aqsa. Guardatela. Guarda questo.
Rabbi Yosef Mizrachi calls for false flag to escalate war:
“Missiles will hit [Al-Aqsa] and clear a place for the Third Temple. If it was up to me, when [Israel] shoots hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and hits it.”pic.twitter.com/cg1X6J4wAI
— Chris Brunet (@chrisbrunet) March 2, 2026
«Se dipendesse da me, l’ultima volta che hanno lanciato centinaia di missili, farei finta che un missile provenisse dall’Iran e lo abbatterei. Sai, allora tutti gli arabi si schiereranno contro l’Iran e sarà la fine dei problemi. Li fai combattere tra loro, questo branco di lunatici. Non è mai troppo tardi, hai a che fare con un branco di codardi».
Aiuta Renovatio 21
Abbattetelo sulla Cupola della Roccia ad Al-Aqsa, distruggete quello che gli israeliani chiamano il Monte del Tempio sulla prima pietra, distruggetelo e date la colpa agli iraniani. E questo ha l’effetto, come avete appena sentito dire, di mettere i nostri nemici gli uni contro gli altri. Mettendo i nostri nemici gli uni contro gli altri, anche se si rifiutano di riconoscerlo da un bel po’ di tempo, gli europei sono i nemici. I nemici mortali degli israeliani.
Questa è la prospettiva israeliana, ovviamente. Guardate gli effetti. E quindi, se ciò dovesse accadere in questo conflitto, non sarebbero gli israeliani a sopportarne il peso. Sarebbero gli europei, i canadesi, gli australiani, noi e i russi. Il 20% della Russia è musulmano. Tutti questi paesi sarebbero destinati a una situazione seria. Tumulti e spargimenti di sangue, e forse già a breve dall’inizio della guerra. Metteteli gli uni contro gli altri, avete sentito dire dal rabbino. Ora, come potrebbe andare a finire?
Molto semplice. L’Iran sta inviando droni e missili in Israele in questo momento, soprattutto a Tel Aviv. È forse inimmaginabile che, nella nebbia della guerra, uno di quei missili colpisca la Cupola della Roccia, o che gli sia stato detto che è successo? E naturalmente, durante una guerra, la prima cosa che si vede è la censura, quindi è molto difficile sapere cosa sta succedendo. Lo si vede già oggi. Ci sono meno o più video disponibili su Internet oggi rispetto a ieri, relativi a questa guerra? Beh, ce ne sono molti meno, ovviamente. Questa si chiama censura. Stanno censurando i video di ciò che sta realmente accadendo. Succede in ogni conflitto. Ogni guerra innesca lo stesso ciclo in patria, lontano dai combattimenti.
Censura e persecuzione. Censura e persecuzione, persecuzione di… nemici, reali o percepiti, delle persone contrarie alla guerra, e la censura delle loro opinioni. Quindi in quell’ambiente, quando non puoi sapere davvero cosa sta succedendo, a migliaia di chilometri da qui, all’improvviso, il complesso Auxa è appena evaporato. Ops, sono stati gli iraniani. Poi abbiamo questo dibattito. È come un bombardamento di un ospedale a Gaza.
Chi l’ha fatto? Beh, è stato un booster di un razzo di Hamas. Beh, come faccio a sapere che non ero lì? Tutto ciò che sappiamo è che è sparito. Oh, mi dispiace tanto. Potrebbe succedere? Oh, sì, potrebbe succedere. L’esercito sta combattendo con le toppe del Terzo Tempio sulle braccia, sulle uniformi ufficiali. E cosa succederà poi? Una guerra di religione globale.
Parliamo di una posta in gioco elevata. Pensavi che le armi nucleari fossero una posta in gioco elevata? Almeno le armi nucleari finiscono in fretta. Ci sono sopravvissuti. Una guerra di religione generazionale?
È peggio di qualsiasi virus e più mortale. Potrebbe succedere. I responsabili sanno che potrebbe succedere? Alcuni di loro sì. Non sembrano preoccupati, dovrebbero esserlo. Dovremmo preoccuparcene tutti e faremo rumore al riguardo.
Iscriviti alla Newslettera di Renovatio 21
-



 Pensiero5 giorni fa
Pensiero5 giorni faEcco la guerra globale per l’anticristo
-



 Comunicati2 settimane fa
Comunicati2 settimane faIn morte di Albachiara
-



 Comunicati2 settimane fa
Comunicati2 settimane faAddio Albachiara
-



 Vaccini2 settimane fa
Vaccini2 settimane faProgetto Artichoke: 70 anni fa la CIA discuteva di nascondere farmaci per il controllo mentale nei vaccini
-



 Comunicati2 settimane fa
Comunicati2 settimane faAlbachiara, la militanza, la determinazione cristiana
-



 Occulto2 settimane fa
Occulto2 settimane faPapa Leone XIV nomina a Sassari il vescovo che partecipò all’inaugurazione di una loggia massonica
-



 Morte cerebrale5 giorni fa
Morte cerebrale5 giorni faDichiarato morto, un bambino torna in vita dopo cinque ore: quando la realtà smentisce i protocolli
-



 Spirito2 settimane fa
Spirito2 settimane faMons. Schneider rivela che i vescovi segretamente non si sottomettono agli insegnamenti di Bergoglio